 Filosofia: un soggiorno montano - Massimo Dei Cas
Filosofia: un soggiorno montano - Massimo Dei Cas
Filosofia in montagna: un soggiorno montano potrebbe giovare alla filosofia? Considerato il profilo esangue ed epigonale che la connota oggi, male non le farebbe. La filosofia dovrebbe essere sempre sulle tracce dei molteplici e sorprendenti aspetti che la realtà rivela. Da questo punto di vista un incontro più ravvicinato con la realtà montana, piuttosto negletta ai tempi della sua tradizione classica, sarebbe utile.
La filosofia avrebbe potuto chiamarsi in un sacco di altri modi. “Scepsi” (ricerca), per esempio, o, ancora, “matematica” (ciò che vi è di più degno d'essere appreso), “cosmonomia” (studio dell'ordinamento del cosmo), “ontonomia” (studio sull'ordinamento di ciò che è), “filaletìa” (amore per la verità), “minervica” (l'arte cara a Minerva, così come “musica” è l'arte per eccellenza cara alle Muse), “istoria” (o storia, indagine su come le cose davvero stanno, condotta con i propri occhi), “logagonia” (lotta di argomenti contrapposti). Alla fine, fra tutti i possibili nomi, ti vien fuori, appunto, “filosofia”. Probabilmente perché i genitori, già separati ed in forte dissidio, hanno voluto ciascuno metterci un pezzo. Così l'amore (filo) viene dal mito, la sapienza (sophia) dalla matematica.
La riflessione sulla mortalità dell'uomo è terreno che la filosofia ha sempre sentito come proprio, magari un po' in condominio con la religione. Ma, ed ecco forse il motivo profondo del suo mal sottile, è molto meno avvezza a pensare di essere essa stessa mortale. Eppure accoglie nel suo ambito non poche figure che ne hanno preconizzato la fine: notoria, infatti, è la generosa tendenza ecumenica ad ascrivere alla filosofia personaggi che tutto avrebbero voluto essere chiamati fuorché filosofi. È del tutto realistico pensare, in un futuro più o meno prossimo, una koinè culturale nella quale la specifico della filosofia sia semplicemente perso. Una cultura, dunque, nella quale non hanno più cittadinanza domante che si riconducono al nodo primo del pensare filosofico: a partire da che cosa si afferma ciò che si afferma? E questo fondamento, a sua volta, a partire da che cosa lo si afferma? E così, ancora e ancora. Se l'uso del logos, la ragione-parola, è derubricato a pratica biologicamente fondata, ovvero ricondotto alla storia evolutiva del genere umano, allora, secondo una ben nota istanza neopositivistica e wittgensteiniana, i problemi filosofici non vanno risolti, ma dissolti, e la domanda filosofica è priva di senso.
Il memento mori è giunto alle orecchie della filosofia, ed è cosa che, una volta udita, segna indelebilmente il tono della rappresentazione e del pensiero. Un'umanità futura che non capisce, semplicemente, il senso di una domanda filosofica non è prospettiva inverosimile: è la prospettiva dell'egemonia della retorica, dell'interminabile chiacchiera che relega la dimostrazione alle scienze formali e lascia, per il resto, campo libero al pathos ridotto ad emozione. Si tratterebbe di una vera e propria riforma, o rivoluzione, nel senso etimolologico e quindi antico dei due termini. Riforma, “reformatio”, ritorno alla forma originaria. Rivoluzione, “revolutio”, rivolgimento che riporta un corso circolare alla sua origine. Sarebbe, insomma, una riconduzione della filosofia alla sua forma primigenia, pratica cui si dedica un'umanità eccentrica, strana, forse anche un po' pittoresca, sicuramente legittimata ad esprimere questa sua singolarità nella policromia delle espressioni della cultura, senza, beninteso, alcuna pretesa egemonica. La filosofia andrebbe così incontro non propriamente all'annientamento, ma alla sua riforma-rivoluzione, proprio nel tempo in cui queste parole hanno dimenticato la loro origine e designano una costante e costitutiva proiezione verso il futuro, piuttosto che l'ancoraggio ad un fondamento originario da recuperare sempre ed ancora.

È ignobile approfittare della debolezza della gente. Ma la filosofia non è la gente. È una matrona stanca, provata (voler tutto provare, alla lunga, a questo conduce). Non si arrabbierà troppo se ne approfitto per tentare una biografia non autorizzata. Una biografia rozza, davvero tranchant, che riduce all’osso la vicenda di quest’ossuta ma non ancora doma anziana signora.
Della sua nascita dico che è strettamente legata a quella della geometria, ad un incontro, intendo, illuminante, l'incontro con la necessità logica, il non poter non essere. Il sempre venerabile padre Parmenide lo enuncia a chiare lettere, parlando però non della cristallina trama degli enti geometrici, ma dell’ón, diciamo sbrigativamente dell’essere. L’essere è e non può non essere, questa la perentoria affermazione sulla quale si sono affaticate generazioni di studenti in filosofia (dall’umiliazione di essere data in pasto a generazioni di studenti, sia detto per inciso, la filosofia non si è ancora ripresa ed al buon padre Parmenide nessuno ha avuto l’animo di dirlo). La meraviglia di cui si dice sia origine della filosofia è probabilmente l'avvertire una dimensione toto coelo diversa rispetto all'universale fluire della contingenza.
La necessità ha un suo luogo, un suo ubi consistam: diciamo, con i greci, il lógos (parola, discorso, ragione). La filosofia si costituisce su questo fondamento, il lógos ne è il Sancta Sanctorum, le sue vie qui portano e da qui si diramano. Fermo restando che, ad onor del vero storico, nella sua storia la filosofia è sempre stata magnanima nell’accogliere nel suo seno molto di più, comprese molte figure che l’hanno anche sprezzantemente negata (in generale mi pare che fra gli aspetti meno nobili della filosofia vi sia una sorta di reverenziale sussiego verso quei saperi cui solo con fatica o per nulla riesce ad accedere, intendo le varie e sempre più articolate e tecniche diramazioni della scienza; di contro ad un poco filosofico atteggiamento di sufficienza nei confronti dell’arte, della letteratura, della musica – basti consultare la ridda di manuali che ne custodiscono la sintesi: vi si cercherà invano un Leopardi, uno Schoenberg,…).
Necessità e lógos sono, dunque, terreno nativo della filosofia. Forse anche per questo la filosofia non ha mai avuto, propriamente, un’infanzia, ma è nata già seriosa ed adulta, consegnata per vocazione al culto di Minerva. E fin da subito ha trovato i suoi detrattori, piuttosto acuti e caustici. Ovviamente anch'essi reclutati entro il solco del suo millenario percorso (quelli più pericolosi, intendo; degli altri antidoto fu l’indifferenza). Gorgia, forse, è la figura più rappresentativa di questa anti-logia: rovescia irridente i principi parmenidei e mostra, al di là dell’irrisione, quale sia il logos che signoreggia sulla condizione umana, non quello di geometri o filosofi, ma la parola, potente signore che trattiene l’uomo entro il proprio sortilegio o incantamento. Ci vorranno quasi due millenni e mezzo perché la filosofia approdi all’intuizione originaria gorgiana: parola e discorso sono il nostro mondo, l’universo nel quale siamo da sempre iscritti inscritti. Un universo senza necessità, se non quella di un perimetro di significati e significanti della cui costituzione, in fondo, nulla sappiamo. Ma non anticipiamo troppo.
Quando, mai giovane ma pur sempre nel pieno del suo vigore, la filosofia si afferma in quella che chiamiamo cultura occidentale, si costituisce anche come tradizione: nella fitta trama dei suoi conflitti e delle sue contese, si scorge un patrimonio comune riconducibile, sempre di nuovo, all’apodittica della necessità: i filosofi, con pazienza implacabile, la scovano nei principi e nei fondamenti, e con rinnovata perentorietà affermano il non poter non essere come dimensione fondante di ciò che, a qualsivoglia titolo, è.
Un non poter non essere che non risalta dai singoli elementi della realtà, ma dalla loro costituzione strutturale, da quel quid che non è mera somma di parti, ma principio che pone in essere le parti come tali (lo diciamo di un organismo vivente, lo diciamo del nostro essere un “io”, lo diciamo del kosmos, l’ordine che è il mondo). Un non poter non essere che si annuncia anche nella suprema domanda metafisica: perché il mondo, piuttosto che il nulla? (detto altrimenti: così come esiste una ragione per ogni singolo aspetto del reale, vi deve essere una Ragione per il tutto della realtà, una Ragione per cui la realtà esiste piuttosto che non esistere, una ragione per cui l'intero della realtà è e non può non essere).
Da questo punto di vista (espressione filosoficamente detestabilissima) nulla di veramente tellurico accade prima del Settecento, prima di David Hume. Il quale, per formazione storico, decide di emulare il grande sir Isaac Newton e di inaugurare una nuova grandiosa scena di pensiero, la scienza della mente umana, che redima la tradizione filosofica dall'irriducibile vizio della frammentazione e del disaccordo. Lo scandalo nasce dalla parte che ha sopravanzato il tutto: la scienza, un tempo esercizio del logos all’ombra del maestoso albero della filosofia, se n'è andata per le sue vie, ha costituito un sapere davvero fondato e condiviso ed ha gettato il più profondo discredito sull’antica madre, che ancora si affatica su problemi sterili, producendo una ridda di dottrine inconciliabili. Ed allora l’historèin di Hume, quello sguardo cattivo ed impertinente di chi vuol davvero vedere con i suoi occhi, dichiara che l’antica matrona (si arrossisce al solo pensarlo) è senza veli, perché la necessità, nella trama dei fatti di cui è costituita l’esperienza, semplicemente non esiste. Sua dimora è piuttosto la trama delle idee. I problemi filosofici nascono da una singolare illusione percettiva: crediamo di scorgere, nella successione dei fatti, una sorta di ombra, un fantasma che tutti li stringe insieme, la necessità, appunto. Crediamo. Ma, ad uno sguardo più attento, dobbiamo con disincanto scoprire che nel cadere dei fiocchi di neve tutto possiamo vedere ed intravvedere, tranne l'ineluttabilità della loro danza. E se poi volessimo, per elaborare questo lutto, consolarci pensando che il logos, lo sguardo che scova la necessità, resta pur sempre consegnato alla dimensione del dover essere, alla morale (già, curiosa e rivelativi sovrapposizione di significati: necessità del non poter non essere e del dover essere…), anche qui siamo costretti ad un’amara disillusione: non vi è modo alcuno di ricondurre il discorso sul dover essere a quello sull’essere. Come dire: l’essere non ha in sé necessità alcuna, ma, quand’anche l’avesse, questa non potrebbe in alcun modo costituire il fondamento della necessità morale. Da ultimo, come ultimo accordo di un de profundis impietoso: dei classici problemi filosofici (compreso quello dell’oggettività e della sussistenza di un mondo “esterno” al soggetto conoscente e dello stesso fondamento sostanziale di questo soggetto) dobbiamo dire che non sono null'altro che imbrattatura di libri degni del fuoco (detto da un bibliotecario!).
Un terremoto. Certo, preparato da qualche sotterraneo, immane e secolare sommovimento. Terremoto di tal fragore da svegliare il monumentale ingegno kantiano dal sonno dogmatico, ovvero dalla pigra fede nella necessità dell’essere. Lo sforzo immane del pensiero kantiano è sforzo di restaurazione, che passa per una profonda rivoluzione copernicana del concetto stesso di esperienza, ma pur sempre una restaurazione, la restaurazione del logos nei suoi diritti sulla realtà. Certo, realtà fenomenica, ma pur sempre realtà piena ed oggettiva, nella quale ogni singolo fenomeno resta incatenato alla ferrea necessità (già, perché ferrea e non aurea?). Kant ce la mette davvero tutta, ed alla fine si risolve ad un azzardo, mai prima e mai più, penso tentato. Mi riferisco alla bizzarra (per anni ci ho pensato, senza riuscire a fugare quest’impressione) dottrina dell’idealità trascendentale dello spazio e del tempo. Architrave senza la quale l’impianto stesso dell’idealismo critico crolla. Come dire: la trama spazio-temporale dell’esperienza ha il suo fondamento nelle forme trascendentali della sensibilità del soggetto conoscente, non nella realtà in sé. Essendo, poi, l'intelletto sovraordinato alla sensibilità, ad esso ed alle sue categorie rimanda, in ultima istanza, la configurazione spazio-temporale dei fenomeni (ovviamente corrispondente ad un ordine universale e necessario). Come dire, di nuovo: se non esistesse alcun soggetto conoscente, non esisterebbero neppure spazio e tempo. Ovvero: la costituzione ultima del tempo è nella dimensione dell’eterno (la non temporalità; e fin qui nulla di nuovo sotto il sole della più autorevole tradizione filosofica), ma di un eterno nel quale, enigmaticamente, ogni singolo soggetto è, da sempre, innestato. Un rompicapo. Forse, però, un rompicapo che ci riconduce al caput Nili stesso della filosofia, a quell’enigma del pensiero da sempre ancipite, sospeso fra tempo ed eternità (a che altro allude il mito Platonico dell’anima che nella sua vicenda trapassa, come un pendolo, dal tempo all’eterno, dalla malattia della corporeità alla pietosa terapia della contemplazione della pura necessità di ciò che è?). Ecco, di nuovo, mi pare, l’origine: nel pensiero che accompagna la mia faticosa vicenda temporale vivo un’esperienza che allude ad un radicale altrove, quella della necessità che è da sempre, quella dell’eterno: quando mai potè nascere, nell’universale divenire, un teorema? E come pensare che di esso, quand’anche nessun pensiero più lo potesse pensare, possa essere nulla?
Sia come sia, Kant era convinto che lo scetticismo, vale a dire la demolizione dell’universalità e necessità del sapere scientifico, fosse una sorta di catastrofe di civiltà. Convinzione che oggi fa sorridere. A meno che intendesse una catastrofe della civiltà filosofica: in tal caso aveva colto nel segno.
La catastrofe venne. Dopo la scossa più disastrosa, altre seguirono, di assestamento (ma anche di sgretolamento di un edificio profondamente segnato dalla prima). L’ottocento ce ne offre un ampio campionario. Se ancora Hegel, osservando con buon senso contadino che da sempre siamo costituiti nella fibra più profonda dallo spirito del nostro tempo, concludeva che non possiamo pensare sensatamente che ciò sia bizzarria del caso, ma dobbiamo pensarvi lo sviluppo del Logos, ecco Schopenhauer individuare nella trama del principio di ragion sufficiente null’altro che l’aspetto formale del copione insensato della tragedia che ciascun vivente è costretto a recitare (ma la necessità è dura a morire: eccola qui nella forma della costrizione). Fin troppo facile sarebbe convocare sul banco dei testimoni Nietzsche e la sua concezione della necessità-fato che insieme è caos, cioè assenza di principio d’ordine e di senso immanente all’essere (senso è solo ciò che vogliamo, senza fondamento e ragione alcuna, che sia).
Di un edificio crollato restano macerie. Dalle macerie è sempre possibile costruire dimore meno ambiziose. Il lutto del logos universale è stato elaborato percorrendo i sentieri di un logos senza fondamenti, che conduce, dalla ragione universale, al discorso temporalmente determinato, ed infine alla parola. Un’eco potente nel novecento filosofico ottiene la tagliente sentenza di Wittgenstein (eco che giunge dall’antica sardonica voce gorgiana): il linguaggio circoscrive interamente il mondo ed i problemi filosofici tradizionali sono semplicemente insensati, come insensato è cercare di scorgere il fantasma della necessità nell’immaginario interstizio fra i fatti. Un’eco che segna la cosiddetta “svolta linguistica”: tutto è linguaggio, il linguaggio è tutto. Sempre più timidi sono gli irriducibili cultori dell’antico logos, che ancora credono nella sensatezza della domanda originaria: ma, alla fin fine, come può essere che al nostro pensiero, stretto in una selva di lacci temporali, contingenti e biochimici, si affacci la verità intemporale?
Se dovessi azzardare una definizione dello spirito del nostro tempo, direi che è dominato dalla sistematica del logos (parola, discorso, chiacchiera) interminabile: la struttura della nostra esistenza sembra conformata in modo tale che ogni sua piega possa essere raggiunta dal logos insinuante ed onnipervasivoile. Il logos che (ancora Gorgia) incanta, consola come un ritmo sonnolento ed un po’ anestetizza, sottraendoci all’orrore di qualcosa che sopravanza la morte (questa, forse, neppure la possiamo davvero pensare): il silenzio.Che ne è della filosofia, oggi? Dispersa in mille rivoli, resta, però, per buona parte entro un grande bacino, trattenuta da una sorta di complesso di Edipo. Niente a che vedere con la psicanalisi: se Freud sottolineò, della tragedia di Edipo, l’involontaria uccisione del padre e le nozze con la madre, possiamo qui assumere come paradigmatica, nella sua vicenda, la risoluzione dell’enigma della Sfinge: l’animale celato dietro il triplice incedere a 4, 3 e 3 gambe è l’uomo. Il complesso di Edipo porta oggi la filosofia (ma è faccenda iniziata almeno un paio di secoli fa, già ben evidente nella costituzione della filosofia trascendentale kantiana, che relega la realtà in sé a concetto-limite) ad una sorta di riflesso (in)condizionato: qualunque sia il quesito, ovunque sia in gioco la realtà e la sua costituzione, la risposta è: l’uomo. Beninteso, non il soggetto consapevole capace di autodeterminazione, non l’io trasparente a se stesso, piuttosto un abisso senza fondo che è l’orizzonte entro il quale si costituiscono le strutture fondanti del senso, del significato, del logos-parola-discorso. Ma pur sempre l’uomo, che ha costituito se stesso come luogo di una nuova metamorfosi della necessità, del non poter non essere (agito, attraversato, parlato,…). È come se quest’essere appena emerso da una vicenda di lunghissima soggezione alla natura, appena emancipato dalla paura, si senta già così importante da pensare di poter erigere la sua muraglia cinese, lasciando nell’oltre lo sterminato spazio delle terre barbariche, della realtà barbarica, e coltivando la sua propria realtà, o semplicemente, la realtà. Nei modi più raffinati. Nella limpidezza dello sguardo fenomenologico al quale la realtà si mostra in una sorta di aurorale costituzione, piuttosto che nell’anti-pathos strutturalista della morte del soggetto attraversato, agito, parlato da qualcosa che è altrove, o, ancora, nella desolazione esistenzialista del disfacimento del senso nell’assoluto vuoto della libertà. Per quanto tutto ciò appaia il trionfo della scepsi antiumanistica, tutto accade al di qua di questa muraglia, nell’urbanissimo impero del logos umanizzato. Un tempo il buon Aristotile si lasciò scappare che, in qualche modo, nel conoscere il pensiero “tocca” la realtà. Oggi il pensiero filosofico, emancipato dall’antica superstizione della necessità, ha interiorizzato un dolente scetticismo e paga la sua disincantata e desolata urbanità con un che di stantio ed asfittico, che fa tornare alla mente, con acuta nostalgia, il monito shakespeariano: vi sono più cose in cielo ed in terra di quanto la filosofia possa immaginare. E la montagna sta proprio fra terra e cielo.
Ma la filosofia, nel suo dolce e collinare paesaggio dove tutto è coltivato, non se la passa affatto male. Più e più volte ha da se stessa ed in se stessa annunciato la propria morte, con gesto scaramantico, ed eccola ancora lì, a ritagliarsi il proprio spazio nella sistematica del logos interminabile. Non è difficile scorgere, qua e là, domande di filosofia, e, senza neppure doversi riciclare troppo, i filosofi entrano nel consiglio di amministrazione delle questioni più diverse, passibili di un risvolto etico. La crescente domanda di mediazioni dialogiche segna un rigoglioso fiorire di figure filosofiche che avanzano il proprio diritto di primogenitura ogniqualvolta vi siano da rannodare fili, da intrecciare discorsi. Un filosofo è meglio di un torturatore, così sentenzia con mite ironia Rorty: ed in effetti contro la feroce tendenza a dissezionare, più o meno metaforicamente, l’altro, la paziente pratica della decostruzione-ricomposizione-interpretazione-interpellazione-… dell’altro crea un tipico effetto di sospensione, nel quale la parola dispiega l’inesauribile ricchezza delle sue trame. Si tratta di un curiosissimo effetto, come di un volteggiare senza peso: è la nuova filosofia senza fondamenti, disincantata ed impenitente, che ha disvestito il lutto per la perdita del logos tangente alla realtà, protetta dalla sua sterminata muraglia dall’assoluto a-logico. Nell’attesa epigonale, forse, di un evento epocale che abbatta quella muraglia. Un evento che accade, peraltro, da sempre, nella vita di ciascuno: un improvviso mal di denti, una perdita senza risarcimento,…
Ho la netta impressione che, dopo questa tirata, la filosofia, se non avesse ben altro a cui pensare, potrebbe colpirmi con una sferzante rampogna: è fin troppo facile evocare con una retorica un po’ bolsa il silenzio, e nel contempo evitare la pratica del silenzio e cedere all’intemperanza della parola (scritta). Ovvero: parlando del silenzio, hai perso un’ottica occasione per tacere.

Alla lavagna! Antico imperativo capace di suscitare ancora qualche eco di profondo timore. Le lavagne, quelle antiche, sono destinate, pian piano, ad estinguersi, per far posto a nuovissimi strumenti multimediali. Il timore di una chiamata alla lavagna scema, anch'esso, pian piano. Oggi alla lavagna sono chiamati un po' tutti, insegnanti, dirigenti, famiglie, costume e società. Gli studenti, da buoni ultimi, dovrebbero sorriderne, se fossero sufficientemente attenti per cogliere quanto le cose siano mutate. O se avessero sufficiente consapevolezza per immaginare una svolta epocale. Ma andiamo con ordine e, per accondiscendere alla malinconica filosofia, chiamiamo innanzitutto alla lavagna la pedagogia.
Questa è data per assente. Ritirata. Non c'è più. Al suo posto figura la neo-iscritta figura, idra dall'unico corpo e dalle molte teste, delle Scienze della Formazione e dell'Educazione. Ma alla filosofia questo poco importa. Ripiegata nei suoi ricordi e delle sue nostalgie, la seriosa matrona si lascia un po' andare e confessa le sue mancanze di madre umana, troppo umana. Per una buona madre tutte le figlie dovrebbero essere uguali, ugualmente amate. Non così per la filosofia. Di tre sue figlie illustri, pensa e sente cose molto differenti.
Perla dei suoi occhi è la scienza, del cui distacco non si è mai consolata, non si è mai fatta una ragione. Ancora la insegue, la spia, la corteggia, ricevendone spesso indifferenza e supponenza, quasi fosse un genitore ormai privo del lume della ragione.
Vero e proprio fastidio prova, invece, per la psicologia, che davvero non sopporta per la sua supponente pretesa di rileggere secondo schemi superficiali tanti secoli di riflessione sull'uomo e sull'anima. Non vi dico delle sue reazioni scomposte, indegne di una augusta matrona, quando sente parlare di attivazione di questa o quell'area del cervello quando si percepisce, o ricorda, o pensa qualcosa: come se davvero l'uovo di Colombo che dipana la matassa delle contraddizioni umane fosse proprio lì, in quella localizzazione. Ma ciò che più la manda in bestia (cosa oltremodo disdicevole a dirsi della filosofia) è constatare di quanto rilievo sociale e peso sulla scelta dei destini dei singoli la psicologia sia oggi depositaria, a fronte della pressoché totale insignificanza del sapere filosofico in tanti secoli di faticoso lavoro.
Della pedagogia, infine, la filosofia non si duole, non si duole del suo distacco. Lascia con indifferenza che la pedagogia se ne vada per la sua strada, perseguendo con petulante pedanteria il suo accreditamento nel club esclusivo delle scienze. Oso chiedere ragione di questa indifferenza. Ne ricevo uno sguardo di severo rimprovero: come, non sono i pedagogisti stessi, quelli più avvertiti, a mostrare la patetica fragilità di questa bambina mai cresciuta? Non era tal Claparède che, alla soglia mai veramente varcata della trasmutazione in scienza denunciava i profondi limiti della pedagogia tradizionale, in primis il suo verbalismo ed il suo appiattimento sul principio di autorità? Sono davvero cambiate, nella sostanza, le cose? Sul verbalismo non parrebbe. Non accade solo in pedagogia, ma il feticismo sulle parole qui è davvero infantile. Alimentato da sempre nuove formule, che riaprono antichissime contese su cosa sia veramente questo o quel concetto. Socrate stesso non avrebbe l'animo di investire con la sua critica interrogazione tanta pochezza: sarebbe come sondare le capacità atletiche di un corpo gracile e malato. I concetti portanti del sapere pedagogico sono una sorta di terreno torboso.
Che vorrà dire, per esempio, educazione? La filosofia, soprattutto la filosofia nel suo soggiorno montano suggerirebbe, forse, che anche per questa via ci si faccia carico della profonda povertà dei nostri tempi, di quella eclisse del rilievo che tutto dispone su una eguale pianura. Orientare rispetto ai valori, o più semplicemente rispetto al rilievo delle cose, ecco un'ottima definizione, attualissima, filosofica, epocale. Attendere i giovani al varco ed incalzarli con quesiti sul rilievo. Non conosci dove sia il Mincio? C'è Google. Non conosci quale siano i rischi di catasfrofe locale e globale, economica ed ecologica, morale ed esistenziale, che si disegnano sul futuro non troppo remoto, nella propria esistenza e nella dimensione universale? Google non ti aiuta granché. Ma, certo, si tratta di rispondere a quell'antica domanda, filosofica anzichenò, se sia meglio aumentare il dolore, l'angoscia perfino, con l'aumentare il sapere, o rincorrere i mille rivoli di un sapere che non angoscia. Tanto, poi, magari le cose andranno comunque come dovranno andare, che venga su una generazione consapevole ed angosciata o inconsapevole ed angustiata.
Di fronte a questa bella possibilità di recuperare alla pedagogia un rilievo epocale, non pare che la scuola sia molto attenta, pronta. Anche la nuova frontiera della didattica per competenze, che porta a compimento una riflessione, opportuna ed intelligente, sul primato del saper essere all'altezza di una situazione problematica come orizzonte di senso del sapere e del saper fare, anche questa riflessione, pare, non ha portato ad evidenziare la competenza delle competenze, la capacità di cogliere il rilievo delle cose. Contro il mito dei miti, il torpore del tempo dell'oggi, la favola della rassicurazione totale. Guarda caso, anch'essa profondamente infantile.
Nelle fantasie infantili a tutto c'è rimedio, tutto si può sanare, ogni incubo può dissolversi in una finale pacificazione. Una fantasia di questo genere percorre l'immaginario contemporaneo. E la scuola ne è protagonista, e ne è forse anche lusingata, oltre che stremata. Si parli di omofobia, femminicidio, bullismo, cinismo, fragilità degli adolescenti e quant'altro, alla lavagna finiscono società, famiglia ma anche, e spesso innanzitutto, la scuola. Cosa fa la scuola? Spesso è pericoloso presidiare il singolare, quando un concetto andrebbe pensato nella sua pluralità. Ma qui davvero la cosa va a rovescio: l'unità dell'educazione come compito essenziale per la consapevolezza delle nuove generazioni viene dissolta (nel pedagogese di preferisce dire “declinata”, chissà perché non “coniugata”...) nel plurale delle educazioni: alla salute, all'affettività, alla legalità, alla convivenza democratica, ed ancora sessuale, alimentare, stradale, ambientale, estetica... Tutto per essere all'altezza di un nuovo mandato sociale (si dice così): cosa fa la scuola di fronte a queste emergenze sociali?
Per inciso, da anni circola la formula dell'emergenza educativa. Se ne parla sempre più spesso, soprattutto quando si riscontra nei bambini e nei ragazzi (a proposito, in tema di bonifica del linguaggio, sarebbe tempo di liquidare i “ragazzini” e di bandire ogni forma di diminutivo: sarebbe davvero già molto...) un senso sempre più esangue dell'autorità, della correttezza verso sé, i pari, gli adulti, una personalità tanto fragile quanto egocentrica, un ego tanto poroso quanto grandioso, da vero e proprio messia venuto al mondo perla gioia di genitori ed adulti adoranti. Ben venga questa consapevolezza. Ma non siamo distanti dal concetto di educazione come percezione, esperienza, sentimento del rilievo: si tratta, qui, dell'esperienza dell'autentico rilievo del proprio io, che non è il faro di Alessandria, ma una luce fra luci, una scintilla fra scintille.
Auspicare che gli insegnanti siano missionari è davvero una cialtroneria (o una strategie per giustificare la loro costante retrocessione retributiva). Enfatizzare come paradigma l'insegnante che vuol bene, che si dedica agli alunni con un profondo investimento affettivo è una cialtroneria. Sarebbe già molto se gli insegnanti volessero bene, davvero, a se stessi. Affermare che la scuola ha un'anima o non ce l'ha, e che quest'anima è una fede, e questa fede è credere profondamente nel compito di educare al rilievo, questo è sacrosanto. Purtroppo, come spesso accade nelle cose della scuola e non solo, il pendolo indugia agli estremi, ed assume la sua massima velocità nella sezione mediana: dall'insegnante missionario, nume di una scuola che non educa alla libertà, all'asettico professionista, grigio e un po' smarrito operatore di un Golem senz'anima, la transizione è breve. L'insegnante consapevole del rilievo educativo della sua figura sta, appunto, nel mezzo. La transizione, semplicemente, lo sorpassa, passa oltre.
Nell'andare oltre, da estremo ad estremo, però, non poco si conserva dell'estremo opposto. Il principio di autorità, per esempio. Nella pedagogia la fa da padrone. Nuove parole d'ordine vengono lanciate, la nouvelle vague del sapere pedagogico viene affermata come frontiera da presidiare, senza che vi sia davvero pensiero di tutto ciò. Chi l'ha detto?, ecco una semplice domanda capace di generare sano smarrimento. Se la capacità di smarrimento (quello critico) non fosse merce rara nella scuola (e non solo). I più scettici e disincantati osservano che nel turbinare delle formule lo scenario è quello gattopardesco, tutto cambia perché niente cambi, o meglio, nel mutamento approdiamo ad isole che, a ben vedere, sono già state scoperte da secoli. In effetti, un po' è così. A leggere i pedagogisti del passato trovi formule che ti colpiscono per la straordinaria attualità e che ti danno l'impressione di una sorta di pedagogia perenne, che non tramonta mai proprio perchè attende sempre una sua transizione alla pratica scolastica. Diceva, per esempio, Pestalozzi che nell'insegnare bisogna puntare sulle “idee-madri”, quelle che da sé ne generano altre, cioè che consentono all'alunno di procedere da sé nell'incremento del proprio sapere. Che è, poi, il nucleo profondo di una competenza.
In questo discorso a ruota libera (a proposito: la nouvelle vague pedagogica sottolinea che niente a scuola deve essere condotto a ruota libera) devo aver qualche volta usato l'aggettivo “critico”. Sarà che si tratta di uno di quei termini che mettono d'accordo tutti e che non fanno arricciare il naso neppure alla filosofia. Una pedagogia critica: possibile? Nel sentire comune, nelle attese sociali, nei riti della rassicurazione totale di cui si alimenta una civiltà post-nichilistica la pedagogia, come d'altronde già da tempo con sicumera fa la psicologia, dovrebbe porsi come tecnica di gestione e risoluzione dei problemi che si danno in quel della scuola, problemi di apprendimento, problemi di fragilità, problemi relazionali. Come si fa quando... Ora, talvolta, nell'ambito, soprattutto, dei processi di apprendimento adottare strategie ed accorgimenti opportuni aiuta. Ma non sempre, e solo entro certi limiti. In generale, porre l'accento su questo versante della pedagogia, come se fosse un ricettario per il problem-solving universale, significa cullarsi nell'antichissimo mito dell'onnipotenza, onnipotenza pedagogica. Sarebbe già molto, davvero, se, per converso, la pedagogia servisse ad evitare errori, a porre in chiaro ciò che non va fatto. Ecco, mi pare, la profonda curvatura critica di cui la pedagogia e la consapevolezza della propria professionalità negli insegnanti dovrebbe alimentarsi. Un tema classico di una parte significativa del sapere novecentesco: incerto, oscuro, perfino, è il senso positivo del valore, o del rilievo, molto più netto è, invece, il suo contorno in negativo.
Una breve lista di ciò che non si dovrebbe mai fare, nell'educare e nell'insegnare, a questo punto non ci sta affatto male.
Alimentare il mito delirante dell'onnipotenza pedagogica, innanzitutto, mito caro a tutti, insegnanti, alunni, genitori. All'alunno perché gli permette di vivere il proprio problema come problema dell'insegnante. Forse è un po' scadere nel caricaturale, ma non troppo, osservare che fino a qualche decennio fa solo con vergogna e titubanza si segnalava all'insegnante di non aver capito, in parte o in toto, una sua spiegazione (in genere si preferiva dissimulare l'incomprensione, anche per evitare di far nascere un'idea negativa nell'insegnante, che poi questo avrebbe indelebilmente conservato). Oggi lo sguardo dell'alunno che non ha compreso ha un certo qual severo cipiglio, come se dovesse uscirsene, parafrasando una celebre frase da gag, con un “facce capì...” Ora, se un insegnante volesse attestarsi sull'idea, un tempo dominante, che il problema dell'incomprensione è problema dell'alunno, sarebbe tacciato, a ragione, di volersela fare facile, di voler tornare ad una scuola che seleziona senza porsi il problema di chi procede con ritmi differenti, frenato da ostacoli epistemologici che gli impediscono un'effettiva comprensione e che non di rado possono essere individuati e rimossi. È la vecchia storia del pendolo: dalla scuola come campo di battaglia in cui ciascuno si deve temprare da sé alla scuola come alveo protettivo in cui a tutti viene promessa una personalizzazione padagogica ed un corredo di strategie ad personam, perché nessuno sia escluso dal successo scolastico. In mezzo starebbe il recupero del sano ed antico principio di ogni arte (arte “artigianale”, e tale, per molti aspetti, è la pedagogia), intesa come “recta ration factibilium”, cioè come concetto corretto di quel che si può fare (e, aggiungerei, ferma volontà di realizzarlo).
Se c'è una pedagogia perenne, è perché ci sono errori, orrori, forse, educativi mai morti. Allora ben vengano nuove generazioni di pedagogisti che ancora scrivano di quanto deformante sia l'umiliazione. Sì, perché accade ancora che a scuola si umilii. Magari in forme un po' aggiornate. La scuola è un contesto di gruppo. Le dinamiche di gruppo sono brutte bestie. Nel gruppo l'essere umano esprime il meglio, ma spesso anche il peggio. E l'insegnante stesso, magari inconsapevolmente, può diventare artefice di una quotidiana crocifissione di persone che hanno pochi strumenti per difendersi. Crocifissione che diviene tale proprio perché si consuma in una dimensione pubblica.
La matassa è, però, più aggrovigliata. L'umiliazione, infatti, è, spesso, nella “cosa stessa”, per usare un'espressione cara a molta filosofia tedesca. A scuola viene in chiaro (il che non significa che venga percepito) qualcosa di profondamente radicato nella nostra civiltà, forse nell'essere umano qua talis. Cosa sarebbe disposto a sentirsi dire un genitore del proprio figlio? Che è disattento? Che è demotivato? Che non si impegna? Sì, in fondo sono rilievi che non suscitano gioia, ma che si è disposti ad accogliere. E se invece si dovesse sentir dire che è meno intelligente della media? Beninteso, penso che nessun insegnante oserebbe parlare con questi termini. Ci vorrebbe un ampio corredo di perifrasi e circonlocuzioni. Ma se la sostanza è questa, la ferita è la più profonda. Ecco un bel tema di riflessione filosofica, e di una filosofia di prim'ordine: perché indifferenza, cinismo, demotivazione, malvagità, perfino, vengono avvertite come meno umilianti della stupidità? Ovvero: perché la cosa che ferisce più nel profondo è sentirsi dire o avvertire di essere meno intelligenti di quel che mediamente un essere umano è? Per quale profonda fascinazione l'essere umano è legato al proprio sapere e poter sapere più che ad ogni altra sua dimensione? Ad altri la risposta; qui basti osservare che, essendo la scuola dimensione vocata al sapere (in modo sempre meno clamoroso, ma comunque tutto sommato ancora significativo), è anche dimensione nella quale si aggira lo spettro del più profondo dei timori, o degli orrori, quello della stupidità. Qui, forse, varrebbe la pena di coniare un nuovo locus pedagogico. Lo chiamerei la “pietas” dell'insegnare. Si dice spesso che l'insegnante debba possedere, nel suo corredo professionale, anche significative attitudini empatiche. Giustamente. E la più preziosa empatia è la capacità di cogliere quando e quanto possiamo ferire l'altro. Da qui la pietas, che si sostanzia nel far comprendere a bambini e ragazzi che le dimensioni del “sapere” sono molteplici, e non si giocano solo nello stretto specifico dei saperi disciplinari. Esiste anche il “saper essere un buon...”, qualcosa che può rendere le persone addirittura preziose, agli occhi degli altri, qualcosa da cui nessuno è del tutto escluso. Per converso, è altrettanto vero che ciascuno ha le sue stupidità, e, in particolare, particolarmente profonda è la stupidità del cinismo, della prevaricazione, dell'indifferenza. Nessuno, dunque, ma davvero nessuno è, simpliciter, stupido. Alimentare questa consapevolezza non come pietistica consolazione, ma come filosofica illuminazione della condizione umana, è pietas, ed è anche l'unica sana rassicurazione che la scuola dovrebbe dispensare.

SUPER NIVEM DEALBABOR (SARO’ PIU’ BIANCO DELLA NEVE – SALMO 50)
Fra le tante incombenze della Filosofia (cui essa si dedica, peraltro, ben volentieri, non avendo mai veramente rinunciato al sogno di poter gettare una luce sui fondamenti e sulla ragion d’essere di tutto quanto cielo e terra possono ospitare) vi è stata e vi è ancora quella di gettare la luce del logos sui miti. I miti non si possono difendere, per cui il gioco non è neppure difficile. Ma tant’è. Peggio per i miti.
Non mi sottrarrò all’incombenza e cercherò di sviscerare qualche recondito significato di un paio di miti fra i tanti di cui è ricco il panorama montano.
Il primo è tanto poco conosciuto quanto suggestivo, ed è legato ad un posto bel preciso, il canalone della Vergine, sui fianchi orientali del monte Disgrazia, una delle più suggestive ed enigmatiche icone della solitaria alterigia della montagna, fra Val Masino e Valmalenco. Il canalone scende ripido sul fondo della Val Ventina, che si apre a sud di Chiareggio, ed è occupato da un ghiacciaio ripido ed infido. Una leggenda assai nota fra gli alpinisti vuole che il suo nome sia legato alla presenza della Vergine Maria, cui essi si appellano perché li scampi dagli accidenti sempre in agguato (slavine, cedimenti di blocchi di ghiaccio, scariche di massi). Ma solo coloro che sono puri nel loro cuore possono confidare nel suo aiuto. Tutto qui.
Dietro le scarne ed essenziali linee della leggenda sta il mito che chiamerei della purezza. Una dimensione che è tanta parte del pathos da cui prende vita l’avventura ed il rischio cui si consegnano gli alpinisti. Lo scenario offre i due elementi classici della purezza: la neve e la roccia. Elementi a prima vista dissimili, ma profondamente solidali nel loro rimando all’immateriale. Sì, anche la roccia, che parrebbe rappresentare quanto di più solidamente concreto e materiale si dia su questa terra, in realtà allude, nella sua apparente saldezza, all’incorruttibile, quindi all’immateriale. Credo vi sia un nesso profondo fra il mito della purezza ed il fascino dell’immateriale. Non che la purezza (come, peraltro, il più delle volte viene intesa e vissuta) sia necessariamente disprezzo della materia. Se così fosse, avrebbe ben scarso valore, sarebbe, per dirla con Nietzsche (esperto di cose di alta montagna), mera formazione reattiva, quindi, nel fondo, legata a doppio filo con la dimensione da cui prende con tanta repulsione le distanze.
No, purezza non è repulsione per la materia e per la dimensione sensoriale-sensibile-sensuale, ma una sorta di indicibile nostalgia (cioè, secondo l’etimo, dolore che spinge al ritorno) di una dimensione altra. Freud probabilmente metterebbe in campo quella fondamentale nostalgia per l’inorganico che, nelle sue ultime riflessioni sulla pulsione di morte, vede insita nel vivente e nella psiche che ne è l’espressione. Andrei oltre, direi nostalgia dell’immateriale, quasi fosse un’origine, persa chissà dove, nella quale una parte del nostro essere affonda ancora le sue radici, ed a cui aspiriamo a ritornare. Una parte, dico, perché provo un istintivo timore di chi facesse di questa aspirazione alla purezza il motivo conduttore dell’intera esistenza. E però oggi soprattutto, in una temperie culturale nella quale si arrossisce al solo pronunciare questa parola (così come in altri tempi si arrossiva negandola: una riflessione che condurrebbe lontano…), la purezza merita una rivalutazione filosofica. Mi sembra di vederci anche qualcosa in più di un semplice aspirare alla dimensione dell’immateriale-eterno: mi sembra di poter parlare di un profondissimo bisogno di riguadagnare sempre di nuovo un’origine, il mito di poter sempre di nuovo ricominciare, rinascere: purezza come mito della palingenesi. Mito che alimenta profondamente l’animus di chi affronta disagi, sofferenze, rischi in montagna: è come ritornare ancora una volta all’origine, come dire che nessuna meta, nessuna impresa, nessuna conquista, la si chiami come si vuole, può essere compimento, telos, fine. Sempre di nuovo rinasce la voglia di nuovi percorsi, nuove vie, nuove sfide, nuovi confronti con l’ombra del vuoto e della morte, nuovi approdi ad abbaglianti scenari ed al sincero appiglio delle rocce. Sempre di nuovo si è ricondotti ad una origine: mentre tutto muta, questa rimane, pronta ad accoglierci una volta ancora, fedele. Una vena profonda connette, dunque, fedeltà e purezza.. Tutto ciò, mi pare, dice nel profondo la parola che sopra ho usato, l’immateriale. Perché la dimensione materiale nega questa possibilità del ritorno. In apparenza, la natura sempre si rinnova, sempre torna alla vita, ciclicamente, ma nulla di ciò che è nella natura può questo. Si rinnova lo splendore dei rododendri a giugno, ma sempre altre sono le piante senza le quali nulla sarebbe di questo splendore.
E, per tornare al mito della Vergine, mi pare che esso dica che il più aspro e pericoloso confronto con la montagna vuole questo bisogno di purezza, senza il quale sarebbe interamente destituito di senso.
Per farmi perdonare queste elucubrazioni, vorrei chiudere con una nota dedicata ai cinefili. Pochi sanno che il monte Disgrazia è protagonista di una delle più belle pellicole dedicate alla montagna, “Cinque giorni, un’estate” (1982), del registra austriaco (appassionato di alpinismo) Fred Zinneman (più noto per altri film, come “Mezzogiorno di fuoco”). Credo che il mito della purezza rappresenti la chiave che offre di questo film l’interpretazione più ricca. La vicenda, in sintesi, parla di un innamoramento che lega una giovane all’affascinante zio (un Sean Connery in grande spolvero, reduce da efficaci lezioni di salita alpinistica su ghiaccio). Al di là dell’improponibilità apparente del legame (anche per la sola differenza d’età), esso viene presentato in una dimensione nella quale la passione e l’eros giocano un ruolo molto sfumato e forse anche nullo. I due, segretamente, si ritrovano per una breve vacanza engadinese (Val di Fex). Lui è medico e valente scalatore, lei se la cava. Fra i due una giovane ed aitante guida, che si innamora di lei (e ne è progressivamente corrisposto), e che si ribella interiormente al legame fra loro, considerandolo profondamente ingiusto. Così, dopo alcuni momenti di grande pathos (il ritrovamento casuale in un crepaccio del cadavere congelato di un giovane del luogo, sparito diversi decenni prima proprio alla vigilia delle nozze e da allora sempre rimpianto-atteso dalla promessa sposa: memorabile l’espressione sul volto della vecchia vedova per fedeltà ad un amore mai compiuto), si giunge al culmine della vicenda. Medico e guida scalano insieme la nord del Disgrazia. Sulla vetta, la guida trova il coraggio di esternare tutto il proprio sdegno nei confronti del cliente. Ma non è cosa di cui si possa discutere a così grande altezza, per cui tutto è differito a dopo il ritorno. La via di discesa è, su proposta della guida stessa, proprio il picco della Vergine (in cima al canalone), raggiunto il quale i due si calano in una difficile corda doppia su una parete verticale. Il recupero della corda dopo un tiro innesca, però, un piccolo smottamento di massi che, cadendo, colpiscono la guida, risparmiando il medico, il quale torna, così, avventurosamente al rifugio per dare la notizia della tragedia. Seguiranno funerali ed inchiesta. La giovane, scossa, farà capire allo zio che non ci sarà alcun futuro per il loro legame. Splendide le riprese (un’inquadratura del Disgrazia da prospettiva insolita ci regala una veste inedita e sublime), splendide le musiche. Sono convinto che Zinneman conoscesse la leggenda della Vergine: troppo difficile credere alla casualità di un riferimento topografico così preciso e così enfatizzato, che è scenario del più classico degli enigmi (l’incidente nel quale uno viene preso, l’altro lasciato). Ed allora il film potrebbe anche essere una sorta di interrogativo sul parallelo enigma della purezza. Ancora.
Si dice: onestà intellettuale. Espressione che a me pare disonesta (intellettualmente?), perché l’onestà è onestà e basta. Varrebbe la pena, invece, parlare più spesso di responsabilità intellettuale, che riassumerei così: essere consci (ed operare di conseguenza) che qualsiasi idea, anche chiaramente espressa, verrà fraintesa, addirittura stravolta, perché l’uomo ha più dimestichezza con un sacco di altre cose piuttosto che con coerenza e logica. Di conseguenza: ogniqualvolta si vuol rendere pubblica un’idea, si dovrebbe responsabilmente pensare come potrà essere fraintesa, giocando d’anticipo ed offrendo ogni possibile avvertenza contro questo fraintendimento. Per quel che qui importa, vorrei dire che niente, purezza inclusa, può essere immune da derive e stravolgimenti. Ovvero: l’aspirazione alla purezza è anima non solo di straordinarie elevazioni montane, spirituali, culturali, civili, ma anche di oscene aberrazioni. La purezza può diventare (non serve riportare fin troppo ovvii esempi storici) il cieco mito che nega ed annienta tutto quanto minacci di macchiarla. Corruptio optimi pessima, la corruzione di ciò che è ottimo è pessima, dicevano i latini. Così come la neve, a guardarla da vicino, non è mai pulita, similmente la ricerca della purezza non dovrebbe mai essere dimentica di quel che è la realtà umana e di quanta sobrietà di giudizio essa richieda. Ovvero: lo sguardo che dalla cima si allarga ad orizzonti tersi non dovrebbe mai lasciarsi assopire nell’illusione che tutto quanto sta in basso sia solo bassezza.

Un secondo mito. Meno difficile da leggere, probabilmente. Quello dei cunfinàa, i confinati, anime condannate, dopo la morte, a non poter accedere, temporaneamente o per sempre, né a Paradiso né ad Inferno. Si tratta di persone che si sono rese colpevoli di colpe così spregevoli da essere invise tanto a Dio quanto al diavolo. Gli eretici, per esempio. Ma anche persone di incredibile malvagità. Costoro debbono vagare, inquieti, nei luoghi più remoti, assumendo le sembianze di animali malefici (cani rabbiosi, maiali aggressivi, orsi e lupi feroci) che terrorizzano i viandanti incautamente attardati su sentieri fuori mano dopo il calar della sera. Oppure sono condannati a dar di mazza su grandi pietre in sterminate, remote e desolate gande (fra le più inquietanti, credo quelle dell’alta Valle di Postalesio e della Val Sassersa in Valmalenco), frantumandole in eterno (se ne ode il colpo sordo sempre dopo l’imbrunire). Oppure, ancora, debbono faticosamente spingere su per declivi grandi massi, che alla fine rotolano di nuovo a valle, e così in eterno (secondo il ben noto modulo della fatica di Sìsifo).
Che significato attribuire a questa credenza? Potremmo leggervi il pensiero che vi sia una sorte ancor più terribile dei supplizi infernali: la condanna all’inanità eterna, a fare cose che non portano a nulla, non hanno alcun significato. Nello scontare una pena vi è un significato: la pena infernale è centrata sulla sofferenza che è espiazione e che quindi ha una sua ragion d’essere e quindi un suo significato nell’economia del tutto. Essa contribuisce in certo modo a reintegrare un’armonia che l’atto malvagio ha intaccato. Frantumare in eterno pietre frantumate in un’inutile ganda non ha, invece, alcun senso: niente viene reintegrato, tutto si frantuma, sempre più. È, cioè, una sofferenza che, nel modo stesso del suo darsi, si manifesta come priva di senso, produttiva, cioè, di frammenti, anzi, di frantumi. Che è quanto come dire: di vuoto, di nulla. E ciò è ancor più vero se pensiamo alla versione montana del mito di Sisifo.
Dietro queste leggende potremmo però scorgere anche un secondo significato. Scriveva Adorno, da quale parte, nei suoi “Minima moralia”, che di persone davvero malvagie non si riesce neppure a pensare che possano morire. Così il confinato che continua a terrorizzare anche dopo la morte è forse trasposizione immaginifica di questo tragico pensiero: i grandi artefici del male hanno in sé qualcosa di orribilmente grande, tanto da indurre a credere che neanche la morte possa fermare la loro malvagità. Il che porta, scavando, a chiedersi quale sia la radice di quella potente fascinazione che porta individui straordinariamente malvagi a riscuotere tanto successo e seguito. Una mediocre cultura storica basta a renderci tristemente persuasi che sia così. Resta la domanda sul perché sia così.

Omne trinum perfectum, tutto ciò che si articola in tre momenti è compiuto. Ecco, dunque, una terza leggenda di interesse, credo, anche filosofico. Si tratta della leggenda dei Corni Bruciati o del monte Disgrazia, comprensorio di impressionanti rocce rossastre che coronano la valle di Preda Rossa, in Val Masino. La leggenda vuole che un tempo i Corni Bruciati non fossero, come ora, desolate torri di roccia rossastra, ma bei pizzi alle cui falde si stendevano, nelle valli Preda Rossa e Terzana, splendide pinete e pascoli rigogliosi.
Vi giunse, un giorno, un mendicante lacero ed affamato, che si rivolse, per essere ristorato, a due pastori, l’uno di animo buono, il secondo di animo gretto e malvagio. Quest’ultimo lo schernì e gli disse che poteva offrirgli solo gli avanzi del cane, mentre il primo ne ebbe pietà, lo rifocillò e gli cedette il giaciglio per la notte. Il mattino seguente il mendicante prese in disparte il pastore buono e gli ordinò di lasciare subito Preda Rossa per salire a Scermendone e tornare a Buglio, senza mai voltarsi, qualunque cosa avesse sentito alle sue spalle.
Il pastore vide il suo aspetto trasfigurarsi, divenendo luminoso e maestoso, e capì che si trattava del Signore, per cui obbedì senza indugio.
Lasciata Preda Rossa, cominciò a sentire alle proprie spalle un gran fragore, grida, rumore di piante e massi che rovinavano a valle, ma proseguì il cammino, ricordandosi dell’ingiunzione del Signore. Quando, però, ebbe raggiunto il crinale di Scermendone alto, e si accingeva a scendere verso Buglio, non resistette, volse lo sguardo. Fece appena in tempo a vedere uno spettacolo apocalittico, un rogo immane che divorava i boschi, ma, ancora di più, la stessa montagna, che si sgretolava e perdeva enormi massi, i quali precipitavano, incandescenti, a valle. Vide solo per un istante, perché fu subito accecato da due scintille, che lo avevano seguito. Pregò, allora, il Signore che lo perdonasse per la disobbedienza, e questi lo esaudì, chiedendogli di battere il piede contro il terreno e di bagnare gli occhi all’acqua della sorgente che sarebbe da lì scaturita. Fece così, e riebbe la vista, tornando a Buglio a raccontare i fatti tremendi di cui era stato testimone.
E’ l’ultima parte della leggenda a rivestire un particolare interesse. È chiara la matrice, vale a dire la nota vicenda biblica della moglie di Lot, tramutata in statua di sale per aver disobbedito all’ordine divino ed essersi voltata a guardare l’immane ecatombe che sommergeva la città di Sodoma, annientata dall’ira divina. Perché la punizione divina si estende con tanta severità ad una debolezza che giudicheremmo umanissima, la curiosità?
Qui è in gioco qualcosa di più della banale curiosità. Penso che sia in gioco qualcosa che rimanda al mistero stesso del peccato originale. La tentazione che determina la caduta è così espressa dal serpente: “eritis sicut Deus, scientes boni et mali”, cioè: “sarete come Dio, conoscendo il bene ed il male”. L’accento parrebbe cadere sul primo termine, la conoscenza del bene; forse, invece, è proprio la conoscenza del male la radice avvelenata della natura umana. Meglio: la maligna attrazione del male, il suo fascino sproporzionato rispetto a quello del bene. Nella sistematica del logos interminabile, cioè nell’apparato universale che moltiplica la chiacchiera e le sue occasioni, il male sopravanza di gran lunga il bene. Ciò che è oscuro, maligno, degenere riveste, agli occhi dell’uomo, una fascinazione ben maggiore del bene. Il quieto splendore di un tiepido meriggio o la pietosa quiete di un notturno nel quale riposa intenerita ogni cosa raramente catturano la nostra attenzione. Non sopportiamo, invece, di non poter fissare lo sguardo nella pioggia di fuoco nonostante ad essa ci è dato di essere sottratti. Non sopportiamo di non poter guardar bruciare ciò che vive e ciò che non vive. Non sopportiamo che tutto ciò se ne stia alle nostre spalle, come qualcosa che potremmo oltrepassare. Il male lo vogliamo di fronte. E questo ci perde, perché quel male vive anche del nostro sguardo.
Ancora sul peccato originale.
Mi accompagna da sempre la sensazione (come chiamarla diversamente?) dell’immane sproporzione del male rispetto al bene. A tutto vantaggio del primo. Forse per questo i filosofi, quasi sempre innamorati dell’armonia e delle simmetrie, hanno immaginato che debba esserci, in una diversa dimensione, quantomeno un riequilibrio. Paradigmatiche le riflessioni, quasi gemelle, di Rousseau e di Kant: se l’esistenza fosse interamente circoscritta nel tempo, essa null’altro sarebbe se non il trionfo dell’assurdo per cui il male ottiene una gratificazione incomparabilmente superiore rispetto al bene; paradigmatico è, ancor prima, quel passo del II libro della Repubblica – che andrebbe letto in ogni corso di Filosofia antica – nel quale Platone dimostra che nel mondo, per quel che effettualmente è, il malvagio perfetto (che, come tale, riuscirà a farsi passare per buono) ed il buono perfetto (che, ignaro di ogni affettazione, sarà fatto passare per malvagio) avranno sorte opposta, il primo ottenendo ogni onore, il secondo andando in contro ad atroce supplizio.
Diversi sono i motivi di questa tragica disarmonia. Compresa l’ignavia e la dabbenaggine del bene (o di quel che è tiepido bene). Il male ha troppi vantaggi: può colpire per primo e quando vuole, può scegliere il tavolo sul quale giocare, può mutare le regole a proprio piacimento. Non ha perplessità, non ha dilemmi, non ha scrupoli. Di più: solo quando è mediocre viene biasimato, ma quando è davvero grande suscita spesso ammirazione e quando è davvero smisurato lo si può vedere solo da una certa distanza (temporale), perché nella prossimità temporale scompare agli occhi dei più proprio per la sua enormità. Unico efficace argine di questo male è che esso, come ogni grande cosa, genera sazietà, e possiamo quindi per un certo tempo respirare al riparo di questa sazietà.
In buona sostanza, sarà pure banale, a dar retta alla Arendt, il male, ma sicuramente è radicale, come afferma anche Kant, e solo con profonda malafede l'uomo inventa sempre nuove fantasiose forme della sua proiezione fuori di sè.
Nella spicciola esperienza della quotidianità del male si mostra il fascino della redenzione possibile e del malvagio si spia e si loda copiosamente ogni spiraglio di ravvedimento, addirittura se ne osanna la conversione; se poi non si converte, sarà sempre un potenziale convertito. Il bene, invece, viene davvero apprezzato solo se è senza residui; ad essere buoni ad intermittenza si alimentano solo aspettative che, deluse, suscitano più risentimento che gratitudine. Il bene mediocre non pare aver alcun pregio. La sua colpa apparente è di essere insipido. La sua colpa reale è di essere troppo ignavo e neghittoso. Qualunque prepotenza, per quanto minima, venga lasciata correre per mero amore del quieto vivere, moltiplica il male. Di questo il non prepotente dovrebbe farsi carico. Ma, come la dolente esperienza di chi vive in montagna insegna, al buono troppo spesso viene negata non solo la felicità, ma anche l’energia che meriterebbe.
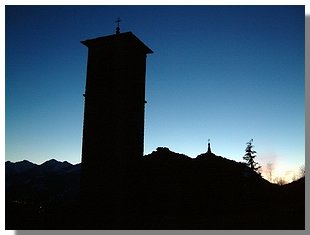
Nella cultura degli uomini di montagna banale è la distinzione fra agnello e montone (o ariete). Si tratta del maschio della pecora, ancora cucciolo, cioè entro il primo anno di vita (agnello) o cresciuto (montone). Nel primo caso abbiamo un animale indifeso; nel secondo un animale che, messe le corna, possiede con queste un’arma di difesa-offesa, un combattente che intreccia duelli strenui con i suoi rivali. La valenza simbolica dell’animale è ben nota nei testi della rivelazione cristiana. In particolare, di Agnello come simbolo del Cristo-Dio immolato si parla nel Vangelo di Giovanni e nell’Apocalisse. I termini greci corrispettivi, però, non sono i medesimi. “O arniós” è, nel IV Vangelo, propriamente l’agnello, “to arnìon”, nell’Apocalisse, è, invece, l’agnello adulto, quindi l’ariete, rappresentato, infatti, nel testo greco con “sette corna e sette occhi”. La differenza simbolica e semantica non è irrilevante. In entrambi i casi emerge netta l’idea della vittoria, ma in una differente configurazione. Nell’agnello indifeso si mostra l’immagine del bene che con lotta contro il male, né si sottrae ad esso, ma si consegna alla passione (nella posizione, appunto, del pathein, del subire). In questo vi è vittoria, ma non vittoria nella contrapposizione, nell’agonismo, nella lotta, ma vittoria nello splendore, cioè nel risplendere della luce abbagliante della risurrezione. L’agnello immolato vince risplendendo della sua totale alterità rispetto alle tenebre che non l’hanno accolto e l’hanno messo a morte. Questo splendore è la sua “dòxa”, la sua gloria, ed in esso consiste l’attrazione di chi, innalzato sulla croce, attira a sé tutti gli uomini. L’agnello-ariete dell’Apocalisse, invece, è segno di una differente vittoria, la vittoria che è esito di una lotta, la lotta delle forze del bene contro quelle del male, di cui nel testo vi sono descrizioni diventate celebri. La sua “dòxa” è la sua potenza, che sbaraglia quella del male.
Ecco, dunque, che la feroce persucuzione dioclenianea, o forse anche altro ancora, fanno nascere nello spirito del cristianesimo qualcosa di inedito ed inaudito: lo spirito di rivalsa.
Cosa scorgere in questa differenza? Una duplicità integrabile o inconciliabile? Vi si può scorgere il farsi storico-mondano del Cristianesimo, un farsi agonistico, attraverso un fitto intreccio di metafore giuridico-militari. Un farsi che prende rivendica per sé, nella forma della verità, categorie mondane e secolari, piuttosto che proporre la radicale mitezza dell’essere totalmente-altro. Tutto qui, il Cristianesimo? Sarebbe ingeneroso affermarlo. La radicale mitezza vive, sempre, in qualche sua fibra, intrecciata però in un robusto tessuto che riveste l’animosità combattente.

Sempre più spesso, dacchè si è diffusa la convinzione che tutto ciò che conta risieda nel linguaggio, ed il linguaggio stesso sia, in certo modo, tutto, le analisi filosofiche prendono spunto dalle parole. Per rinnovare un antichissimo vezzo, quello dello scavo etimologico: nella radice sta la verità…
Allora per parlare di montagna affidiamoci a tre voci greche: óros, che sta, appunto, per montagna, póros, che significa “passaggio”, “via d’uscita”, ed infine “orìzon”, “ciò che delimita”, l’orizzonte, dunque. Come si può facilmente avvertire, le tre parole hanno una comune radice. Il che fa sospettare un legame profondo tra questi significati, legame che riporta a quel che ritengo essere uno dei significati più profondi del vivere la montagna.
Óros-póros: vorrei partire da qui. Prendendola un po’ alla larga. L’esperienza contemporanea (quella di sempre, forse, ma oggi in misura parossistica) mi pare caratterizzata da una crudele tirannia, quella del tempo. Vengono in mente orologi, impegni, appuntamenti, tutta una serie di luoghi comuni sull’inesorabile incombere del tempo nelle pieghe della quotidianità. Sì, ma c’è di più. Penso a come la diffusione dei mezzi di comunicazione capillare fra le persone conferisca al presente la valenza di presenza virtuale e totale di ciascuno a tutti. In qualunque istante posso raggiungere con un messaggio quanti conosco. È come se la distanza spaziale fosse diventata un accidente irrilevante. Tutti sono, nell’istante presente, virtualmente presenti, virtualmente raggiungibili. Ed allora l’istante si affolla in una ressa che genera ansia, e talora è anche letteralmente soffocante.
In montagna tutto ciò pare capovolto. Il tempo deve retrocedere, cedendo il primato allo spazio. E questo permette di respirare. Lo spazio è sovrano, il tempo è ancillare. Non che non conti, tutt’altro: chi va in montagna sa bene quanto sia importante fare i conti con i tempi (per non parlare del tempo atmosferico, la vera incognita perturbante). Ma se vogliamo abbandonarci al sogno di un’esperienza ideale, allora immaginiamo che in essa il tempo non conti più e lo spazio sia, invece, tutto.
La tirannia dello spazio è liberante, ma anche terrificante. Perché lo spazio non è indefinita e domestica apertura, luogo dell’agio confortevole e confortante (a meno che ci limiti ad una innocua passeggiata). Lo spazio è problema, enigma talvolta. Il cammino è ricerca del póros, solo a tratti perspicuo, evidente. Solo in montagna si può istituire un gioco, il gioco dello sguardo che cerca, su versanti, pareti, crinali, il póros, il punto dove si può passare. Un gioco affascinante, che rimanda a qualche remotissima esperienza infantile, come, del resto, tutto ciò che ci rapisce. Un gioco dello sguardo, ed allora conserva il distacco del “divertimento”, ma anche un gioco nel quale possiamo essere presi con ogni fibra del nostro essere. Gioco, del resto, è quanto di più serio vi può essere nell’esistenza: tutto o quasi si può fare a metà, conservando distacco e distanza, tranne che giocare (ciò vale, almeno, per alcuni dei giochi).
Quando siamo in cammino, il póros è gioco sempre aperto nel quale ci possiamo ritrovare o perdere. Perdere il sentiero potrebbe sembrare incidente quasi comico, o seccante, ma per chi lo vive acquista una inquietante valenza difficile da descrivere, un’esperienza di smarrimento che si annuncia, sorda, e minaccia di crescere fino al terrore.
Portata al limite, questa esperienza diventa l’essere presi in trappola: ci si ritrova in un luogo dal quale non ci si può muovere, perché chiusa o quantomeno fortemente azzardata è ogni via. Anche quella che abbiamo percorso per giungere lì. Un termine dialettale in uso in Valtellina descrive questa situazione caratteristica come “incrapelàs”, ritrovarsi prigionieri dei crap, delle rocce. Ne parlano, qualche volta, anche le cronache dei soccorsi alpini.
In questa esperienza il póros si è interamente sottratto. Viviamo la sensazione che cresce fino al terrore, perché la situazione è peggiore del generico essere presi in trappola: se qualcuno ci intrappola, possiamo sperare dalla sua volontà o da qualche altro evento la liberazione. Ma qui niente e nessuno ci può sottrarre allo stallo. Il terrore diventa orrore quando immaginiamo il possibile esito del nostro tentativo di sottrarci allo stallo: precipitare. In montagna non di rado precipitare significa finire in un orrido, appunto, in una forra, in un burrone ombroso, insomma in qualcosa che richiama l’archetipo per eccellenza dell’orrorifico, le fauci spalancate del chaos. Il gioco del póros, come tutti i giochi seri, ha fra le sue possibilità un rovinoso fallimento. Per questo chi cammina è tutto preso dallo spazio, controlla che il póros sempre lo accompagni, nella forma rassicurante del sentiero o comunque del versante agevole. Il timore di essere sorpresi da oscurità o maltempo è superato dalla paura di perdere il póros. Non poter più trovare un per dove si passi è il terrore nascosto. Che forse rimanda alle più cupe ombre che popolano una qualche regione della nostra mente, ombre che riassumiamo nel termine morte. Non sarà che della morte ci terrorizza proprio questo, un non trovar più il per dove si passi e quindi l’essere intrappolati in un fondo oscuro e senza póros?
Intanto, però, in questo gioco che per lo più null’altro è se non vaga apprensione, il tempo e la dispotica tirannia della presenza del presente ha allentato la sua morsa, ed ora, veramente, respiriamo.
Apprensione, paura, terrore: non sono questi, ovviamente, i soli ingredienti dell’esperienza del camminare in montagna. Manca all’appello, infatti, l’orìzon, l’orizzonte.
Un luogo comune che per molto tempo ha dominato l’esprerienza escursionistica ed alpinistica è legato alla vetta: il compimento non può che essere là, al culmine. Forse, però, il concetto di culmine dovrebbe essere ampliato. La legge della buona forma (Gestalt, direbbero i tedeschi) domina sovrana l’esperienza dell’uomo. Ogni esperienza deve avere il suo compimento, e non ce ne possiamo davvero liberare se essa non è giunta alla sua buona chiusura (il che non significa necessariamente favorevole, ma comunque ad una chiusura che le conferisca una configurazione compiuta). Questo accade anche nel frequentare la montagna.
Penso che culmine possa valere come compimento. Ma cos’è, davvero, un culmine? Non necessariamente una vetta, ma ogni luogo dello spazio nel quale vi sia apertura di orizzonti. Il che sulla vetta sicuramente accade, in forma spesso quasi commovente. Ma non solo in vetta. Un passo, una bocchetta, una sella sono ugualmente, sotto questa prospettiva, culmine, apertura di un nuovo orìzon. Il cammino in montagna è una specie di caccia a questi culmini. E quel che si prova quando l’orizzonte si allarga difficilmente lo si può dire a parole. Di nuovo,lo spazio la fa da padrone, non più nella forma inquietante del póros da rintracciare, ma in quella talvolta sublime dell’allargarsi. Che è un po’ il simmetrico ed opposto dell’orrorifico di cui si diceva: ciò che speriamo, per tornare al pensiero della morte, è che questa non sia l’orrore di un buco senza vie d’uscita, ma un aprirsi di un orizzonte che neppure possiamo immaginare. Fantasie sulla morte accompagnano, silenti, il nostro camminare. Fantasie che forse rivelano come l’enigma della morte sia molto più legato allo spazio, che al tempo. Dopo la morte, saremo nell'eterno, cioè fuori del tempo. Ma dove saremo?A proposito del tempo. Una postilla.
A differenza di buona parte, o forse di tutti gli altri animale, l’uomo è attento a tutto tranne che a quello che ha davanti agli occhi. Beninteso, questo vale come metafora, perché, soprattutto in montagna, si deve ben presto imparare la fondamentale importanza di essere attenti a quel che ci sta dinanzi. Intendo però dire: della realtà cui da sempre ci accompagniamo, cioè di noi stessi, vediamo poco o nulla.
Solo a distanza di tempo acquisiamo una qualche consapevolezza di quel che siamo stati, di quel che abbiamo fatto, di quel che siamo diventati. Il tempo, in questo caso, non è gran galantuomo (apre, più che sanare, ferite), o lo è soprattutto per chi incrocia la nostra esistenza e ci trova un po’ più pensosi, quindi un po’ meno scellerati.

I montanari (uso questo termine consapevole della sua sciocca ed un po’ irrispettosa banalità) hanno una loro semplice ma, credo, efficacissima antropologia. Non servono troppe categorie per classificare gli uomini: ci sono i prepotenti ed i miti, quelli che sfruttano gli altri quelli che generosamente donano, i sinceri e gli insinceri, quelli dal carattere forte ed i fragili, quelli che coltivano ambiziosi progetti e quelli che si accontentano di poco. Ma, soprattutto, ci sono i buoni ed i cattivi. Non avrei troppe obiezioni (la filosofia che mi sta accanto, nel frattempo, è troppo assorbita dalla propria malattia od ipocondria per prestare realmente attenzione ad una questione così grossolana).
Solo, mi parrebbe buona cosa distinguere almeno due categorie di buoni, quelli che lo sono per empatia e quelli che lo sono per logica. Questi ultimi sono molto molto rari.
C’è una bontà che si radica in un sentire immediato, indeducibile. Qualunque sia il suo limite (ed un limite, per il montanaro, ce lo deve avere, perché non scada in “coglioneria”), vien fuori spontanea come una risata, dal cuore. La bontà per logica è una cosa un po’ più complessa (non dico complicata). Anche qui c’è un sentire, che però, a differenza del primo caso, si lascia articolare in concetti, il sentire che tutti siamo ugualmente uomini, e che, dunque, dobbiamo pensare alla nostra condizione in universale. Alla Kant. Senza scomodare l’evangelico “non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te” (frase da interpretare non così alla leggera, perché un sacco di persone voglion fare a se stesse un gran male), diciamo, alla buona, che il dover essere consiste nell’immaginare come sarebbe il mondo se tutti, nell’agire, seguissero infallibilmente, per legge stessa di natura, il criterio che detta le nostre azioni. Ne vien fuori che nessun mentitore vorrebbe vivere in un mondo di mentitori, nessun ladro in un mondo di ladri, e così via. Ne vien fuori pure che se un imperativo non è incondizionato, se si mettono di mezzo i “se” e i “ma”, va tutto in malora, perché ciascuno è bravissimo nell’escogitare un sacco di “se” e “ma” che si attagliano perfettamente ai propri particolari interessi.
Ma possiamo addirittura oltrepassare, in questa bontà logica, lo stesso rigorismo kantiano, e ridurre tutto all’osso del principio di non contraddizione. In una parola, ridurci alla pura coerenza. Parolina, questa, cui tutti rivolgono un omaggio di facciata, senza però avvertirne davvero la forza eversiva della comune condizione umana.
Mi appoggio ad un esempio, scolastico (la filosofia, accanto a me, ha come un sussulto: torna al suo meditabondo distacco quando chiarisco che parlo di scuola e non di filosofia scolastica). Gli alunni, in genere, desiderano docenti che valutino con rigore, attenzione, imparzialità, in una parola (spero che la filosofia resti distratta), con oggettività. Nel contempo, però, non considerano colpa grave ricorrere a mezzi e mezzucci per ingannare il docente (suggerimenti, appunti ben mimetizzati, e quant’altro). Al più, pensano, è affare del docente riuscire a scoprirli (nel qual caso è comunque suo buon diritto sanzionare gli incauti o maldestri). Non viene loro in mente (infatti, anche fra di loro i buoni logici sono rarissimi) che ciò equivale a compromettere le condizioni di possibilità stesse di una valutazione oggettiva. In sintesi: sono incoerenti, chiedono l’oggettività e nel contempo operano per vanificarla (un po’ come chiedere ad un pianista di eseguire una sonata con le mani legate). Quando mi capita di cercare di far riflettere su questo aspetto, ho l’impressione che in astratto gli studenti colgano il senso di quel che dico, ma ne siano ben poco toccati. Alla fine mi convinco sempre più che il destino della bontà, nel mondo (parlo di giustizia, pace, solidarietà, ...), resterà sempre affidato ai buoni empatici.
Sto per chiudere queste ultime righe, quando la filosofia, scuotendosi dalla matassa mai dipanata dei suoi pensieri, mi chiede, per puro desiderio di fare cosa grata (forse presa da un’inconsolabile tristezza: i filosofi, penso, vivano l’esperienza della più lacerante solitudine), di cosa stia scrivendo. Rispondo di aver scritto che i buoni logici sono davvero pochi. Ah sì, annuisce, e snocciola qualche nome di valente cultore della logica.
Non si può sfuggire alla questione. È, la montagna, donna? Così è stata pensata, secondo un intreccio di metafore che oggi fanno sorridere. La vetta, la conquista… Mi è accaduto di pensare che se davvero la montagna è donna, lo è soprattutto nel senso che ogni montagna, come ogni donna, ha la sua bellezza, nella luce giusta, nel momento giusto, così come ogni montagna può rivelarsi, in una certa luce ed in un certo momento, brutta.
Ma, insomma, mi pare che la montagna non abbia genere. A proposito dell’onnipervasività del genere e delle questioni di genere nell’uso del linguaggio, la montagna ha qualcosa da dirci? A mo’ di celia si potrebbe rispondere che sì, forse ci insegna che non ha molto senso il tentativo di aggiustare il genere di un sostantivo conformandolo al genere della persona designata. Intendo dire, in montagna una guida alpina è spesso assai utile. Verrà un giorno in cui, in nome dell’aderenza del genere, si parlerà di guido alpino in presenza di un aitante ragazzo?
Proverbiale (anche perché espressa in qualche proverbio) è la fede delle persone che vivono faccia a faccia con l’incombente penuria e precarietà dell’ambiente montano. Una fede radicata. Forse, ancor più, tenace. Addirittura puntigliosa. Una qualche riflessione sulla fede, dunque, non sarebbe davvero fuori luogo.
Oltretutto penso di non dispiacere affatto alla convalescente filosofia scrivendo qualcosa sulla fede. Sua vecchia conoscenza, del resto, con la quale ha costruito una storia di vicissitudini scandite, con ritmo quasi pendolare, da attrazione e repulsione. Se anche la fede passasse di qui, ricomincerebbero a bisticciare, a prendersi addirittura a male parole; tempo una notte, però, ed eccole di nuovo guardarsi un po’ di sbieco per spiare l’occasione di intrecciare una qualche nuova discussione.
Alla fede si deve profondo rispetto. Proprio per questo non si deve parlarne a cuor leggero, anche perché già il parlarne la indebolisce: di parole si alimenta la filosofia (anche se a questo pane ci mette di tanto in tanto il companatico della realtà), di esempi viventi la fede.
Chiederete: perché non invitare anche la fede ad un soggiorno montano, visto che di una sua crescente debolezza si parla sempre più spesso, quantomeno alle nostre latitudini? Perché non è possibile immaginare la fede come personaggio che la montagna possa ospitare. La fede non va qua o là. Piuttosto si mostra, qua o là, e quando si mostra suscita un sempre rinnovato stupore (ecco un bel tema che commuove la filosofia, memore dei suoi esordi). La fede è come una luce ferma, che trattiene l’occhio senza violenza alcuna. Le parole sono penosamente impari a figurarla: essa si vede davvero solo nella persona che ha fede.
Ecco, sapevo che sarei incorso in questa espressione: avere fede. Mi pare tradisca la fede, raffigurandola come cosa che si possa dare, ricevere, perdere. La fede si è, più che si ha. La fede non è qualcosa nel, ma qualcosa dell’essere dell’uomo, ed essa è, con lui, mutevole, contraddittoria, sempre esposta allo scoramento, sempre pronta a ricominciare, sempre esposta alla gioia più radiosa ed alla disperazione più cupa. Detto in termini più filosofici: l'uomo è costitutivamente aperto all'orizzonte della trascendenza.
Eppure moltissimi la pensano come un tesoro e vivono nella paura che possa essere portata via. Sono i credenti che spiano, con occhio diffidente ed impaurito, l’altro, per scorgere se vi sia un egual tesoro, o se costui, per risarcirsi del vuoto nel suo cuore, non voglia fare un egual vuoto nel cuore di un altro. La fede che è l’uomo non teme di potersi perdere, non considera speranza e carità come altro da sé, quasi sorelle di una famigliola nella quale la fede finirebbe per recitare la parte della sorella maggiore, bisbetica e dispotica. La fede teme piuttosto di diventare vuota, arida, rinsecchita, nell’inaridirsi e rinsecchirsi dell’uomo stesso. La fede è grazia perché grazia è l’essere dell’uomo stesso. Si perde solo con il perdersi dell’uomo intero, con il perdersi del senso dell’apertura al Mistero, con la disperazione. Quella disperazione nella quale i teologi hanno voluto ravvisare il misterioso peccato contro lo spirito, l’unico di cui si afferma, nel Vangelo, che non sarà mai perdonato. Cioè che l’uomo non si perdonerà mai, costruendo in se stesso e da se stesso il proprio inferno. Non vorrei che questa chiosa apparisse empia: mi pare che l’uomo abbia tutto ciò che gli serve per apparecchiare non uno, ma molti inferni.
La filosofia getta un occhio su queste righe. Non vi ritrova il proprio elemento, ma non pare neppure troppo contrariata. Ha come l’aria di dire: se la metti così, su cosa potrò più litigare con la matrona rivale? Come potrò punzecchiarla con la provocazione del credere di credere, come potrò infastidirla con il richiamo costante alla ragione che a buon diritto rivendico come mio possesso?
La ragione… Se la sono contesa per secoli. Ora la filosofia rimpiange, quasi, i bei tempi costellati da furibondi litigi. Ma non ha perso il suo piglio. Quasi di getto legge queste righe, e mi apostrofa: usi le tue parole per parlare della fede e dici che le parole la indeboliscono: bell’esempio di coerenza.
Già. Ho perso un’altra occasione per esercitare la virtù della continenza, virtù cardinale, ma forse un po' anche teologale. Ancora sulla fede...
Essendo la fede, della famigliola delle virtù teologali, la sorella maggiore, difficilmente rinuncia alla sua abituale seriosità, imperiosità e dirittura di sguardo. Solo molto malvolentieri si lascia sorprendere nella sua duplice anima. Una duplice anima che però, a ben guardare, si mostra con chiarezza nella storia dell’occidente cristiano. Che è fors’anche duplice anima dell’occidente stesso, un’anima storica e positiva ed un’anima spirituale. Nel rendere ragione della propria fede il credente è innanzitutto chiamato a non mostrarsi un puro folle (va bene parlare di una follia divina a fronte della sapienza umana, perché non si ricorda mai a sufficienza all’uomo l’infinita sua distanza da Dio, ma poi, tornati da questa infinita distanza all’uomo, si deve pur sempre tener fermo che nel credere questi non rescinde i profondi legami che da sempre lo trattengono all’umano). Ed allora le parole che rendono ragione si incamminano su due sentieri differenti. Accade, non spesso, ma accade, in montagna, che ad una medesima importante elevazione conducano due sentieri ben marcati. Ecco, dunque, il sentiero della positività storica: nucleo fondante della fede è l’esperienza sensibilissima, prima che spirituale, del sepolcro vuoto, dell’incontro con il Cristo risorto e con la sua carne. Quest’esperienza diviene tesoro che le generazioni consegnano l’una all’altra. Un nodo storico stringe i secoli e li raccoglie ugualmente tutti attorno a quest’alba,a quest’alpha del credere: solo un Dio, un Signore dell’uomo può vincere la morte. Ma, nell’Evangelo stesso, non si parla solo di un evento che stupisce e va oltre ogni umana immaginazione: il Risorto non si impone all’occhio dell’uomo come una pura evidenza apodittica, non è come il lampo ed il fragore del tuono, non come il colore della rosa, una semplice mero un fatto, ma interpretazione di un fatto, perché chiede all’uomo di essere riconosciuto. Ed il riconoscimento non è atto puramente naturale, come di cane che riconosca il padrone. Qui viene evocato altro, lo spirito, sia per chi vide il Risorto, sia per chi ne ha raccolto la testimonianza. In questo secondo caso, lo spirito è chiamato in gioco per riconoscere, nello sguardo di chi racconta, la genuinità e veridicità del raccontare. Fede è, nel suo primo significato, fiducia nell’uomo. Per questo la fede non ha mai accettato volentieri la scomoda compagnia dei filosofi: se chiedi loro quanto meriti fiducia l’uomo otterrai il più delle volte una risposta profondamente scettica, soprattutto se si sta parlando di pescatori, di gente di nessuna cultura, o addirittura di donne.
Lo spirito salta oltre l’evidenza storica, perché nessuno vide mai, con occhio d’uomo, un mero cadavere rianimato: ci volle il gesto dello spezzare il pane, ci volle la pesca in una mattina uggiosa, ci volle qualcosa di più della semplice presenza di un uomo dalle fattezze ben note. Lo spirito, non le fattezze, rende testimonianza.
Di qui la domanda, quasi mai espressa: perché rendere così difficile la fede? Perché Dio non si è mai mostrato nella sua solare evidenza? Si penserà che una domanda così, mi verrebbe da dire, terra terra i filosofi non se la siano mai posta. Invece, spigolando, trovo in Kant e Kierkegaard due risposte che, da una profonda lontananza filosofica, convergono singolarmente. Se Dio si mostrasse nella sua infinità maestà, annota Kant, il ginocchio dell’uomo si piegherebbe nell’atto della prostrazione. Ma non è questo che Dio chiede all’uomo. Qualcosa di simile in Kierkegaard: Dio vuole dall’uomo un rapporto di innamoramento da singolo a singolo, ed è come re che solo dissimulando la propria condizione può sperare di conquistare l’amore di un’umile fanciulla. Di un rex tremendae maiestatis non ci si innamora.
Carità e speranza leggono con molto interesse queste annotazioni, perché con lo spirito hanno una profondissima frequentazione. La fede appare, invece, piuttosto contrariata. Così son fatte le sorelle maggiori, soprattutto quando le minori le sopravanzano in amabilità e, soprattutto, hanno per sé tutto il futuro....sulla carità...
Ancora. Emmaus è un luogo topico della fede, che vi si mostra come riconoscimento. La fede nel Risorto è riconoscimento del Risorto. Riconoscimento né immediato, né scontato. I discepoli lo riconobbero dal gesto della frazione del pane, non, immediatamente, dalle fattezze. E così anche in altri racconti di apparizione del Risorto ai discepoli, come quello della seconda pesca miracolosa. In quest'ottica la fede è riconoscimento dell'altro nell'altro, riconoscimento che, in ogni singola esistenza, è assai meno banale di quanto si pensi. Nei tratti dell'altro riconosco l'altro, ma accade che questi tratti perdano di significatività. Quando si sfalda l'evidenza del tratto, si apre una dimensione nella quale sperimentiamo un percorso incerto, un percorso che non può disegnarsi se non nella fede. Esperienze limite, come quelle dell'Alzheimer, rendono l'altro un enigma di irriconoscibilità, e ci pongono faccia a faccia con questa irruzione della fede. C'è qualcosa che ci induce irresistibilmente ed irriducibilmente a riconoscere ancora l'altro nell'altro. I tratti, si direbbe. Ma è davvero così? In realtà, cosa ciò sia, non sapremmo dirlo. Adorno definì l'amore come riconoscimento dell'io nel tu. La fede potrebbe essere riconoscimento del tu nel tu.
Anche la carità, come la fede, pare avere due anime. Forse anche tre. Leggendo l’Evangelo, ci imbattiamo nel comandamento dell’amore. Gesù dà ai suoi discepoli un comandamento nuovo: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ora, appartiene alla natura di ciò che viene comandato che non possa essere moto dell’animo, spontaneità, sentimento, cuore. Un vecchio adagio popolare ammonisce che al cuore non si comanda. Dunque pare che Gesù non parli propriamente, o solo di qualcosa che si riduca al cuore. Nell’obbedienza è in gioco l’agire, non il sentire. Ecco un lato della carità troppo poco considerato: carità è agire. Un agire che non esclude il sentire, ovviamente (l’aridità ed il fariseismo sono sempre dietro l’angolo), ma che si pone, come dire, un passo avanti: è innanzitutto questo che ci viene comandato, nei termini della donazione di sé e della gratuità (il che significa donazione di cose, ma ancor più di tempo, attenzione, empatia). L’agire ha una limpidezza che il cuore non può avere: il risolversi o non risolversi alla donazione ha una sua effettualità obbediente, mentre la disposizione del cuore ad un sentimento che dia anima all’azione è piuttosto un cammino lungo ed interminabile, dove non di rado ci si smarrisce e si gira a vuoto.
Ed ancora: risolversi all’azione e por mano alla fatica di Sisifo per gettare un po’ di luce nel guazzabuglio del cuore umano non bastano. Carità chiede anche intelligenza. L’invito hegeliano a considerare che fare il bene è pur sempre l’intelligente fare il bene non viene mai troppo tenuto presente. Ecco la terza anima: carità è anche sforzo di comprensione, non solo del proprio cuore, ma di cosa sia davvero il bene nelle situazioni concrete in cui operiamo e siamo. Il celebre passo paolino, nel quale si dice che la carità non avrà mai fine, potrebbe, con una forzatura (ma la carità tutto sopporta), essere inteso in questo senso: interminabile è il cammino (temporale) che strappa alla penombra ed all’opacità il cuore dell’uomo ed i suoi autentici bisogni. Interminabile, perché alla domanda se sia davvero ed in che forma sia davvero carità quel voler porre la nostra tenda nel cuore dell'altro, di cui sentiamo così forte bisogno, ardua fatica è trovare la risposta.
Tuttavia, se il tempo della chiarezza si dilata oltre misura, quello della risoluzione ad agire deve seguire un moto opposto. Questo richiede la logica del comandamento.
La carità, né la più grande, né la più piccola delle tre sorelle, si dispone prontamente all’obbedienza della maggiore, mostrando alla minore il suo volto amabile: di essa e della sua luce si alimenta, infatti, la speranza, perché nulla potremmo veramente sperare, se non avvertissimo quello che chiamiamo, con termine da usare sempre con ritegno e pudore, amore.
Postilla: quanto spesso nelle comunità cristiane la carità sia stata intesa come gioia dello stare insieme e del condividere, è sotto gli occhi di tutti. Cosa sia, nel suo fondo, questa gioia e questo condividere, è assai meno chiaro. Bisogno di appartenenza e di rassicurazione, dialettica inclusione/esclusione, emotivismo: ci sono fin troppi spunti di riflessione. Contro una tendenza fin troppo forte ad immaginare la carità come promiscuità ed esibizione delle coscienze e dei sentimenti, varrebbe la pena tener fermo, come contrappeso, il lato della sobrietà che giunge all'oblio: se nel fare il bene la nostra mano destra non deve sapere ciò che fa la sinistra, figuriamoci quel gli altri debbono sapere (o vedere)... ...e sulla speranza.
Essendo la minore delle tre sorelle, la speranza è anche quella che mostra un volto ancora indefinito, ingenuo. Qui non ci sono anime diverse, tutto è semplice ed insieme terribile, come nell'essere bambini. Cosa sia proprio della speranza non è ancora chiaro: di lei si dice che debba essere “sicura speranza”, come se fosse ancora interamente sotto la tutela della fede. La fede la tiene sotto la più attenta protezione, perché la speranza mostra, nella sua infantile immediatezza, quell’apertura ad un futuro radicalmente altro che è l’orizzonte stesso di trascendenza costitutivo dell’uomo. La desperatio salutis, la disperazione di potersi salvare, è l’abisso, è non sperare più di poter essere amati. Da questo inferno neppure l’onnipotenza divina ci può strappare.
Nulla possiamo davvero meritare di fronte a Dio, e tuttavia dobbiamo agire come se potessimo tutto meritare. Fra queste opposte istanze si muove, di moto continuo, lo spirito di coloro (non molti) che prendono sul serio la fede.
Al primo estremo, il credente si rende conto che quel che conta davvero, agli occhi di Dio, è il cuore, la purezza dell’amore per lui. Ma la sincerità dello sguardo non può non scorgere quell’oscuro fondo che intorbida anche la più bella delle anime, nel sospetto che il presunto amore per Dio altro non sia che una delle innumerevoli metamorfosi dell’amore per sé, il più istrionico degli attori o dei mimi. Ed allora il credente, al culmine del cammino dello zelo e del fervore, si scopre infinitamente distante da Dio, infinitamente indegno, schiacciato dall’impossibilità di essere davvero, cioè in trasparenza, ciò che Dio vuole. Di qui la preghiera che la grazia colmi l’infinito abisso dell’indegnità umana e che la misericordia accolga anche la spaventevole bruttura del peccato più radicato e radicale, perché di nulla di buono possiamo davvero pensarci artefici.
Ma il moto non può arrestarsi qui. La sincerità dell’ammissione del peccato radicale, unica speranza di salvezza per il credente, è anch’essa sottoposta al sospetto: non potrebbe essere, infatti, anch’essa, di nuovo, l’irridente mascheratura dell’amore di sé e del compiacimento in sé? La coscienza non può, dunque, riposare tranquilla, deve mettere alla prova la sincerità del proprio abbandono alla divina misericordia, e non può farlo se non prendendo su di sé l’assoluta serietà dello zelo e dell’impegno, dell’ascesi, quindi, nel senso etimologico dell’esercizio (“àskesis”). Il credente ogni giorno sale l’ardua china del perfezionamento, della mortificazione, dell’imitazione di Cristo. E se questa salita non è farisaica finzione, egli avverte l’elevazione e, al di là delle cadute, il progresso. Finché, di nuovo, l’istanza del cuore si presenta a fustigare quel fondo di compiacimento che si distende come rugiada del cuore: sei tu, davvero, più vicino a Dio? Novello Sisifo, il credente vede il masso di nuovo ruzzolare giù, ed avverte la necessità di assaggiare di nuovo la profondissima amarezza dell’essere in fondo alla china, e di dover, di nuovo e sempre, risalire.
Tutto ciò nel tormento della sincerità della fede. Nella fede pacificata di molti le cose sono, invece, assai più semplici. Il pensiero nascosto di cui questa si alimenta è, press’a poco, questo: “O Dio, vedi che da me stesso non sono in grado di trar fuori nulla di buono; vedi un po’ tu di fare in modo che questo possa accadere, perché solo tu lo puoi fare”. Qui manca quasi interamente la faticosa salita della china dell’àskesis: ci si siede appena un po’ più in alto del fondo, con l’aria di chi vuol vendere la propria resa per umiltà, come a dire: "quel che sono sono, sarei un gran bel presuntuoso se presumessi di poter fare qualcosa di più rispetto alla miseria della mia natura. Farà Dio quel che vorrà fare, altro non ho da dargli se non la fiducia che lo potrà fare, e con essa preghiere, ed atti di devozione quanto basta.” Il masso resta sul fondo: forse verrà un gran vento, a sollevarlo in alto.
C'è un'antica fra credenti e non credenti.
I primi guardano ai secondi come si può guardare a persone colpite, per una qualche colpa, da un morbo pauroso e contagioso; i secondi guardano ai primi come a degli sciocchi che restano legati ad una visione infantile, favolistica ed altrettanto colpevole della realtà. Commiserazione contro disprezzo, dunque. Questo reciproco sguardo cattivo cela a malapena la profonda paura sottesa.
Lo sgomento del credente di fronte alla malattia del non credente nasconde la paura che le radici della fede non siano poi così profonde come si vuol credere, perché la fede del credente è innanzitutto fede nella saldezza della propria fede, ma l'ateo sembra lì apposta a mostrare una possibile deriva cui tutti siamo esposti.
Il disprezzo del non credente nei confronti del credente cela l'invidia e la paura che la presunta superiorità intellettuale dell'ateo non sia poi così intelligente, anzi, sia una gran fregatura, perché chi crede vive meglio, più serenamente.
I primi, dunque, avvertono i secondi come una minaccia, mentre questi avvertono i primi come un'offesa alla propria angoscia di fronte al nulla. Entrambi, in questo stato d'animo, sembrano accomunati da una profonda non-verità.

DI CIO’ CHE LA MONTAGNA NON HA
Molte sono le cose che la montagna non ha. Non ha genere, penso. Ma neppure parole. Questo le conferisce un valore raro. La montagna non parla, non è madre, non matrigna, non gelosa, non insidiosa, non chiede rispetto, non chiede vite. È semplicemente ciò che è. Vi è una profonda catarsi nell’accostarsi alla montagna, una liberazione dal paludoso universo della parola, del parlare. Bel paradosso: parlare dell’esperienza della montagna come liberazione dal parlare… Ma, dopo il rossore dovuto per questa incoerenza (sono convinto che oggi alla filosofia epigonale rimanga, ancora, un compito profondamente etico, il presidio della coerenza), vado avanti.
Fin dagli albori della filosofia si è affacciata la domanda su cosa sia l’uomo. Se dovessi definirlo così, su due piedi, difficilmente resisterei alla tentazione di definirlo animale cialtrone. Prendo a prestito un’espressione tipicamente aristotelica, il per lo più, vale a dire tutto ciò che nel corso ordinario della natura si mostra, fatta salva la possibilità di accidenti ed eccezioni. Ebbene, per lo più l’uomo è cialtrone, soprattutto quando parla (ed è l’attività che, in assoluto, maggiormente, nella forma immediata o mediata, ama fare). Quel che dice è, per lo più, non vero (non intendo interamente non vero, ma non vero sotto qualche profilo, marginale o essenziale che sia). È come se l’uomo avesse un congenito amore per l’approssimazione: la verità intera no, sempre qualcosa che si approssimi alla verità (o se ne allontani decisamente, a seconda delle circostanze). Per questo le parole, alla lunga, disgustano, sanno di frutta alterata.
La montagna nulla dice. Non mente, non affetta, non simula, non dissimula, non aggrazia, non sfigura. È quella che è. Silenzio profondo.
La montagna è una di quelle rare dimensioni che possono ancora regalare l’esperienza del silenzio assoluto. Non spesso, ma può accadere. Un’esperienza di forte impatto. Già, il silenzio. Termine così lontano dalla dimensione consueta dell’umano. Mi è capitato di pensare che l’uomo ha quasi sistematicamente cercato, nelle sue molteplici espressioni culturali, di rinnovare metamorfosi, che mostrassero una sempre diversa cifra del suo essere. L’inedito, questo nuovo imperativo (ipotetico?). Fra le vie percorse, una manca all’ppello. Quella del silenzio assoluto.
Immaginiamo: un uomo che decidesse (o forse semplicemente, fosse) il silenzio, nient’altro. Un silenzio assoluto. Non parlasse più. Semplicemente. È mai accaduto un uomo così? Se accadesse, cosa significherebbe?
Non saprei. Mi verrebbe da dire che un uomo siffatto sarebbe un elemento di un paesaggio montano. Ma anche marino. Con il che non intendo avallare un antico stereotipo, che vuole le persona di montagna piuttosto taciturne anzichenò. Innanzitutto perché non è vero. Poi perché l’essere taciturni piuttosto che ciarlieri è ugualmente distante dal silenzio. Il silenzio è, innanzitutto, semplicemente silenzio. Poi, se vogliamo intenderlo in senso lato, è sobrietà (non scarsità) della parola, è soppesare le parole. Intendo: non centellinarle, ma cercare di ciascuna il peso e restituirlo, portare in primo piano il significato, anziché la relazione.
Sobrietà: altra voce che ben si accompagna alle divagazioni montane. La montagna costringe alla sobrietà, all’essenzialità. Un tempo, almeno, era così.
E ancora. la perdita del senso del silenzio è profondamente connessa con la perdita del senso del mistico, che nel silenzio trova l'elemento proprio, e che nell'esperienza dello splendore del tutto trova il suo cuore. Tutto risplende, agli occhi del mistico. Nel silenzio.

DI CIO’ CHE LA MONTAGNA RIVELA
Cosa accade nell’andare in montagna? Penso che accada qualcosa come l’attenuarsi di quella opaca anestesia che caratterizza la nostra quotidianità. Nella quotidianità tutto è attutito (quando e quanto può esserlo), dolori e felicità. Andare in montagna significa esporsi al venir meno dell’efficacia di questo farmaco anestetico: ora dolore e felicità si fanno sentire. Se dovessi usare una frase molto logora, in montagna ci si ritrova soli con se stessi. E se abbiamo l’impressione che la montagna ci parli, ciò che udiamo è la voce di noi stessi a noi stessi. Il dolore si rivela, profondo, lancinante. La felicità si svela, luminosa. La montagna ha poco a che fare con le mezze misure. Se il mare induce l'oblio, la montagna riporta ogni sensire alla sua forza originaria.
A meno che, come fanno molti, non ci si vada in vociante ed esuberante compagnia. Ma allora essa diventa solo contenitore di uno svagarsi che potrebbe accadere ovunque. L’esperienza del silenzio montano squarciato dal vociare di gitanti è qualcosa che molto si avvicina al surreale. Oggi è di moda portare la vita in montagna: svaghi, tinteggiatura dell’epidermide, musica, gastronomia. È più che comprensibile. Si potrebbe biasimare il profondo bisogno che l’anestesia della quotidianità ci avvolga, ora e sempre?
La filosofia, nella sua veste critica, ha sempre cercato di smascherare pregiudizi, sofismi, errori, fallacie. Mi pare che ve ne sia una strettamente legata alla grammatica, al numero, al singolare in luogo del plurale. Si tratta di una fallacia già presente nel semplice affermare “la” montagna. Quasi si trattasse di una realtà unitaria, meglio, di una realtà eminentemente unitaria.
La montagna, come un sacco di altre cose, non è una realtà eminentemente unitaria. Pluralità, frammentazione e sfaccettature contano più dell’unità. Ma vi è qualcosa nell’uomo che lo porta a percepire nelle dimensioni della realtà, soprattutto se non le abita, un’unità molto maggiore di quella effettiva. Così, se si va in montagna ci si aspetta di trovare gente che si assomigli, cose che si assomiglino, esperienze che si assomiglino. Poi, a farci caso, si scopre che non è così, e che orrido e sublime convivono quasi fianco a fianco. Cammini accanto ad una mucca che passa un’intera giornata a cacciare mosche con la coda, e ti senti male. Guardi i suoi occhi, e ti colpisce una pace senza nome. Incontri persone che ti salutano cordiali. Altre che sembrano mugugnare una risposta infastidita al saluto, e talora neppure quella. Incontri pigri sacerdoti e sacerdotesse della lentezza e della contemplazione e (spettacolo sempre meno raro) cultori del passo affrettato, quando non della corsa in montagna. Scorgi cime che si stagliano con una forma perentoria e ti suggeriscono l’eterno; ti capita di avere il privilegio di avvicinarle, e scopri ovunque crepe, rughe, sfaldature, segni di un tempo che aggredisce ogni cosa. L’occhio si posa su scenari di una bellezza che fa male, ma anche su quadri di uno squallore deprimente. C’è una montagna allegra, sublime, radiosa, ed una montagna triste, umbratile, agghiacciante, quasi. Dov’è, l’unità? Forse, solo, nella volontà di tornare, ancora una volta.
La montagna parrebbe ben conciliarsi con le riflessioni sulla bellezza. Non necessariamente con la bellezza stessa. C'è un che di insopportabilmente cialtronesco nella bellezza. Qualcosa che sconfina nell'impunità. E nella prepotenza, perché la bellezza non ammette discussioni, è essa stessa l'ultima parola. Così, la bellezza è anche un passepartout, una messa in mora del pensiero, una facile donnicciola che, senza un mimino di buon gusto, si accompagna con tutti, crudeltà compresa, un individuo equivoco che la fa sempre franca. E, fin dalle origini, i filosofi hanno pagato, pesantemente, dazio a questa appariscente gabelliera.
Così i Pitagorici non hanno trovato di meglio che dedicarle l'intero universo, che da allora e da loro chiamiamo anche “cosmo” (belletto, ornamento). Ed anche il buon Platone se ne è lasciato irretire, giudicando l'idea di bellezza la più visibile fra le ombre delle cose (come se questo volesse dire qualcosa). Callìpoli, cioè “città della bellezza”, è il nome che meglio si attaglia alla sua città ideale. Anche tipi piuttosto svegli e disincantati come Kant sulla bellezza hanno scivoloni imbarazzanti, qual è quello di affermare che la sensibilità alla bellezza si accompagnerebbe infallibilmente all'amore per la virtù. Nella cultura greca la mancanza di bellezza è una colpa che non si può espiare. Così giunge fino a noi, ed è ancora freschissimo, il concetto di “kalokagathìa”, inscindibile connubio di bellezza e valore morale.
E se per gli antichi un Tersite è, in ragione stessa della sua deformità fisica, un individuo anche moralmente turpe, ancor oggi ciò che oltraggia la bellezza è una colpa che ogni singolo espia in termini di riprovazione morale. Solo la Sindone, per quanto so, mostra un Cristo nasone; non mi viene in mente alcuna raffigurazione della Madonna che ne mostri tratti grossolani. Se poi trovassimo qualcuno disposto a contrastare la prepotenza dell'appariscente, difficilmente non ne saremmo delusi, perché, invece di attaccare l'inconsistenza della bellezza, si limiterebbe a trasporla in una dimensione altra, quella dello spirito. Bel guadagno! Tutto diventa bello: il gesto, l'interiorità, la vita. Gli argini sono rotti, nulla può evitare un dilagare increscioso e funesto.
E tutto ciò è solo un frammento di quanto si potrebbe dire per mostrare l'imperio del bello. Contro il quale nessuna protesta vale, nessuna lotta può alcunché, anche perché sarebbe una lotta contro un vuoto simulacro, un nome privo di significato che non sia quello che ciascuno vi vuol vedere rispecchiato. Come le cime in una pozza.
Ecco una parola amica della montagna. In montagna, almeno lì, tutto dovrebbe essere libertà. Non arbitrio, ovviamente: si deve essere profondamente responsabili, verso se stessi e gli altri, quando si frequentano luoghi montani, perché spesso basta davvero poco per farsi e fare del male.
Libertà, piuttosto, di essere quel che possiamo o vogliamo essere. La montagna non giudica. Non chiede fatica, sacrificio, sofferenza. Siamo liberi di imporcela. Oppure di lasciare che il tempo scorra via, senza perturbazione, senza sforzo. Siamo liberi di guardare ed ignorare.
Eppure un sacco di gente si porta alla montagna con l’idea di dover assolvere ad un qualche compito: l’escursione memorabile, l’attività predatoria. Quest’ultima è triste. È espressione di libertà, anch’essa (avuto ovviamente riguardo delle normative vigenti, ma questo lo si sottintende sempre), ma di una libertà triste. Come se non si fosse capaci di lasciare che le cose siano. Leggere di persone che mettono a rischio o addirittura perdono la vita per i funghi, tanto per fare un esempio quasi paradigmatico, lascia attoniti.
Lasciare che le cose siano: è una delle possibilità che la montagna offre. Mi pare, la più nobile. Poter dire: ciò che alla montagna ho tolto è solo quel poco che rende possibile un’orma su un sentiero. O ancora, malizia tecnologica, quel poco di luce che rende possibile un’immagine digitale. Un nulla, quasi.
Accidenti, la fallacia grammaticale mi ha indotto ancora una volta in errore: come si può parlare di libertà al singolare? Le libertà sono plurali, e conflittuali. Il che pone un problema filosofico di non poco conto. Perché se assumiamo, con un po’ di approssimazione, che libertà sia sinonimo di diritto, ecco che siamo condotti al problema di come conciliare differenti diritti, eterogenei e conflittuali. Di fronte a tale problema spesso viene posta in campo l’aurea affermazione “la libertà di ciascuno termina laddove inizia la libertà degli altri”. Suona assai persuasiva, ma è assolutamente vuota, nel senso che è come dire che il confine di un territorio è posto laddove inizia il territorio contiguo: è ovvio. Meno ovvio è determinare dove esattamente sia questo confine. Forse qualche situazione montana può aiutarci a riflettere. Ad esempio, come conciliare il diritto di chi cerca in montagna una dimensione di quiete e silenzio e quello di chi anche in montagna vuol portare un irrefrenabile impulso al divertimento ed al rumore?
Ora, di fronte a questo dilemma, come a tutti quelli analoghi, la filosofia mostra che si può cercare una soluzione seguendo due vie, quella della natura e quella della storia. La prima ricerca in principi connaturati da sempre all’umanità in quanto tale una gerarchia di valori alla luce della quale stabilire quale dei diritti in conflitto debba ritenersi più importante. La seconda istituisce questa medesima gerarchi appellandosi alla storia, allo spirito dei tempi, all’ethos, direbbe Hegel, a quella costellazione di valori che concretamente ha effettualità nel presente della storia. Entrambe queste vie sono oggi poste in crisi dalla pluralità dei riferimenti valoriali che connota una civiltà sempre più globalizzata e multiculturale. Dilemmi fino a qualche tempo fa impensabili oggi cominciano ad affacciarsi. Ad esempio: è lecito che le vette siano sormontate da croci, o non sarebbe più corretto rispettare la pluralità delle sensibilità religiose e non “imporre” a tutti i simboli di una di esse?
A volerla pensare, questa situazione è abissalmente complicata. Se rinunciamo alla fede di un denominatore universalmente umano, tutto sembra sgretolarsi. Ma, d’altro canto, dove cercare questo denominatore? Siamo di fronte al medesimo smarrimento che prese i Pitagorici quando scoprirono l’alogon, l’impossibilità che esista un minimo denominatore comune, un elemento che sia contenuto un numero finito di volte nel lato e nella diagonale di un quadrato: l’armonia intera del cosmo parve loro andare in pezzi. La nostra pare essere la civiltà dell’alogon: l’esperienza storica suggerisce che questo sia il destino, lo smarrimento del logos, della ragione intesa come sfondo comune nel quale ogni espressione dell’umano possa riconoscersi. Ma non possiamo a cuor leggero rassegnarci a questo smarrimento.
La riflessione suscitata dal fastidio per gli schiamazzanti frequentatori della montagna porta lontano. Anche se, alla fin fine, non essendo il pensiero attività peculiarmente connaturata all’uomo, scivoliamo quasi ineluttabilmente in qualche cortocircuito e tagliamo il nodo gordiano alla maniera di Alessandro, secondo la logica dell’è così perché è così, perché così sento, perché così mi pare che debba essere, perché così credo.
Ecco, se dovessi snidare una profonda solidarietà fra montagna e filosofia, mi verrebbe da esprimerla così: in entrambe le dimensioni la ricerca delle scorciatoie è tanto allettante e comoda quanto pericolosa.

La luce avvicina al sentimento del sublime. Uso questo termine impropriamente, non ne trovo altri. Qualche volta, in qualche momento, non frequente, si mostra la luce. Nessuna esplosione, nessun tripudio, ma una quieta gioia. Non quando il sole batte a picco, schiacciando tonalità e sfumature con la prepotenza del suo fulgore. Ma, quando ancora o già basso, lascia che il colore delle cose si accenda e si mostri. Allora l’occhio partecipa di un incanto senza nome.
C’è qualcosa di materno nella montagna? Forse solo quando nebbie e brume avvolgono ogni cosa. Ed allora, se non sei disperso, ti senti nascosto al mondo. Ed allora ti può afferrare un grande conforto, un calore, perfino, come da madre che ti preserva.
Se non fosse che la montagna nulla insegna, potremmo dire che è maestra di dolore. E che svela il profondo legame fra amore e dolore. Non, come si crede, legando il dolore all’amore deluso, ma piuttosto a quello che maggiormente si accende ed avvampa. Solo il più profondo amore, quando non è deluso e non delude, ci espone al più grande dolore, la lancinante consapevolezza di non poter poter prendere su di sé il dolore della persona amata, di poter far soffrire la persona amata del nostro stesso soffrire. Dolore più grande non penso possa esserci.
Quando lo si prova, si indivia la roccia.
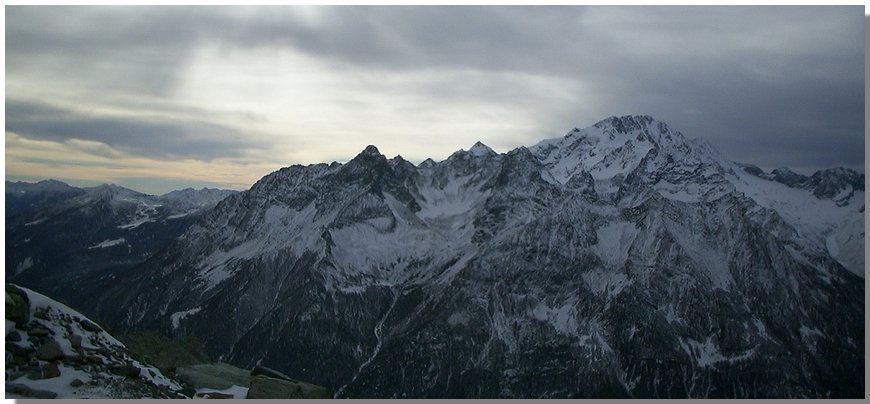
Fra i filosofi più alla moda, e da diversi anni, sicuramente si pone Nietzsche. Il che è fargli un torto non da poco, considerata la sua repulsione per la popolarità. Ma tant’è, sic transit gloria mundi. Dovendo, quindi, pagare dazio ed unirmi all’oltraggio, mi tocca una citazione. Opto sicuramente per la riflessione (vado a memoria) sul legame fra pensiero e movimento: non si può pensare davvero stando fermi, ma solo essendo in moto. Ecco, dunque, un nuovo nesso fra filosofia e montagna ed una spiegazione del profondo amore del filosofo per l’alta montagna.
Mi pare vero: il cammino è dimensione assai propizia per il pensiero. Ma, di nuovo, questo è uno dei motivi per cui l’andare in montagna è insidioso: i pensieri vengono, e sono spesso cattivi, come sale su una ferita. Per questo sempre meglio dotarsi di amici ciarlieri.
Montagna e solitudine: altro binomio che pare scontato. Una solitudine che da mera situazione fisica diventa pensiero. Può capitare che si pensi: in questo istante nessuno sta pensando a me. Ebbene, che cosa sono, ora? Che ne è del mio essere, così radicato, nella sua essenza, al pensiero altrui? Se la montagna fosse maestra, ci inviterebbe a riflettere su quanto il sentimento del nostro essere, prima ancora che del nostro valere, sia consegnato alla rappresentazione altrui. Sembrano esserne consapevoli i bambini stessi, fin da piccolissimi: imporsi all’attenzione, questo conta più di tutto. È universalmente noto il cartesiano “cogito ergo sum”, “penso dunque sono”; seguendo il filo di questa specie di esperimento mentale, parrebbe forse più giusto affermare “cogitor ergo sum”, “sono pensato, dunque sono”. Ed ora che vaghiamo nella solitudine e possiamo ben presupporre che nessuno ci pensi, che ne è di noi? Questa domanda può essere tanto angosciante da portarci ad immaginare che la montagna stessa abbia occhi per osservarci, oppure può essere avvertita addirittura come liberante. Un vecchio tema, questo, il naufragio nell’immenso mare dell’essere e la profondissima quiete ad esso legata. Che altro è, per noi, questo mare immenso se non essere nulla nel pensiero altrui? Per tutto questo, una parola, oblio. Ma il fruscio di un piccolo ramo di larice accarezzato dal vento basta a strapparci da questa abissale rappresentazione: ecco, qualcuno torna a parlarci.

DELL’INGENUITA’ CHE CI HA LASCIATI
Là dove il vuoto s’infrange, o forse trattiene la sua furiosa voracità, lì è la montagna: le cose potrebbero essere viste anche così. Il cammino di salita diventa, prima o poi, un esporsi a questo vuoto, un rimanere sulla sua soglia. La natura ha orrore del vuoto, sosteneva il pensiero antico. E con essa l’uomo. Orrore, ma anche fascinazione: nell’animo dell’uomo il vuoto suscita sentimenti che poco si lasciano rischiarare. Se ci interroghiamo sul senso dei passi più esposti alla possibilità del vuoto, siamo costretti a fare i conti con questo interrogativo: cosa abbiamo a che fare, noi, con il vuoto? Cos’è questa profondissima repulsione, che grida dal profondo del nostro essere, questo aggrapparci spasmodico alla vita, ed insieme questo essere qui, esposti, sullo stretto filo percorrendo il quale sentiamo l’agghiacciante alitare del vuoto? Che senso ha, tutto ciò? Che senso ha il rischio?
Il rischio è ovunque, si potrebbe rispondere. Ogni meta espone a rischi.
Ma questo è un rischio del tutto particolare. Guardare negli occhi ciechi del vuoto non è come guidare pericolosamente, od esporci a qualsivoglia altro comportamento a rischio.
Per cercare di scandagliare, per quel po’ che è possibile, questo enigma, forse è utile prenderla molto alla larga.
Vi fu un’epoca, lunghissima, segnata da una concezione dell’uomo lineare, logica. La filosofia antica lo mostra nella forma più evidente. Erano tempi in cui i Neoplatonici potevano pensare che l’uomo fosse in grado di ascendere (il neoplatonismo è filosofia che trova nella montagna profonde analogie), fino ad una semplificazione, fino all’unità perfetta. La semplificazione! Per l’uomo!
Erano tempi nei quali il discorso etico si dispiegava nella sua luminosa logica assiomatico-deduttiva. Assioma: ogni uomo tende alla felicità. Constatazione: gli uomini vivono nell’afflizione. Deduzione logica: l’uomo perde la via, cerca, per ignoranza, la felicità là dove non la può trovare. Terapia: la ragione filosofica mostra quale sia veramente la felicità, addita all’uomo il corretto sentiero che ad essa conduce.
È forse poco più di un secolo, forse qualcosa in più, che questa consolante immagine è andata in pezzi. C’è più di un buon motivo per credere che fra le aspirazioni più profonde dell’uomo la felicità sia qualcosa che non occupa necessariamente il centro. Forse vi si trova altro. Forse un’angoscia sorda, l’oppressione del nulla, il bisogno di sfuggire a questo vuoto anticipandolo, sfidandolo, guardandolo in faccia. Chi non vorrebbe, nell’ansia opprimente di una prova terribile (un’operazione, una notizia,…), affrettare il passo ad essa? Anche il Cristo prega Giuda di affrettarsi a portare a compimento quel che è scritto. Perché, con Kierkegaard, possiamo convenire che la possibilità è la più gravosa delle categorie.
Se così è, l’uomo può essere pensato anche come colui che anticipa ed evoca questo buio vuoto, tessendo tragicamente la trama della propria infelicità. Perché l’infelicità ha questo vantaggio sulla felicità (qualunque cosa essa voglia poi dire), placa un poco quest’angoscia del nulla, evocandolo e guardandolo negli occhi senza fondo (anche i bambini avvertono che l'orrore più profondo si stempera se assume un volto, ed allora non se ne stanno con le coperte sul capo, ma guardano fuori e chiamano il lupo). Mentre la felicità è sempre disarmata ed esposta all’irruzione del nulla. Non così l’infelicità, che l’attende e lo provoca, armata, sfidandola, come a dire: che hai da togliermi, ora?
Difficile, oggi, dire che ciò cui tendiamo, nel fondo, tutti, anche se con diversa consapevolezza, sia la felicità. La presenza del vuoto, che in montagna ci fascia da ogni lato, apre questo pensiero. Ne esce come un conforto, perché il passo che ci trattiene dall’abisso è una sfida, un confronto. Nel salire, in forme più o meno ardite, l’uomo si commisura con molte cose, con gli altri, con se stesso, ma forse soprattutto con il vuoto senza sguardo.
Alla fine, si pensa un po’ tutti, qualunque rischio ci si sia assunti, ne valeva la pena. Forse possiamo giungere a pensare che l’esporci al rischio della montagna non è fra i modi più oscuri di alleviare l’angoscia del vuoto senza fondo. Molte sono le vie. Vie più luminose, come l’abbandono ai molti volti della fede. Ed altre ancora, moltissime altre, anche le oscene vie che moltiplicano nel mondo inferni che è penoso nominare. Ma, sia come sia, il volto senza sorrisi della montagna sembra indurci al rossore per aver voluto tanto a lungo credere alla nostra inequivocabile vocazione alla felicità.Ancora.
Le generalizzazioni non colgono mai pienamente nel segno. Non è vero, in particolare, che il pensiero dei secoli passati non abbia mai avuto sentore dell'oscena attrazione che il nulla esercita sull'uomo. Penso, ad sempio, a Sant'Agostino, il quale, riflettendo sul male, nelle Confessioni, racconta di un giovanile furto di pere, atto di per sé, in apparenza, di non eccezionale malvagità, in realtà rappresentativo del male più radicale, cioè del male gratuito. L'uomo può volere il male non per mero errore od ignoranza, ma proprio perché male. Ma ciò significa che ama la propria morte, il proprio annientamento, il nulla. Questa è, per lui la radice ultima del male morale, di cui il male fisico, la sofferenza e la morte, sono conseguenze. Ancora.
Non vorrei con le mie riflessioni aver offeso la suscettibilità degli alpinisti. Non intendevo certo affermare che la pratica dell'alpinismo sia circoscrivibile nella dimensione del bisogno di un faccia a faccia con il nulla. Credo, però, che anche questo ci sia. Nell'alpinismo come in un sacco di altre cose. Aggiungo queste considerazioni per evitare la replica piccata: bella forza, che altro ci si può aspettare da un consumascarpe (categoria che mi descrive perfettamente) che per ignavia e pavidità (verissimo) non si è mai cimentato con l'alpinismo, che altro se non malcelata invidia? Ancora.
La teoria agostiniana della cupiditas (l’amore rivolto alla creatura che sopravanza quello per Dio, la caritas) ne individua tre forme fondamentali: il desiderio di conoscenza, il desiderio di dominio ed il desiderio carnale. Di questi, l’ultimo mi pare quasi accessorio e derivato: nel fondo, al di là della componente strettamente ormonale, è perlopiù una sorta di disperazione mascherata, quasi un ripiego, per colmare il vuoto di altri desideri. Desiderio di conoscenza e di dominio, infatti, lo sopravanzano di gran lunga, quando si fanno avvertire e possono essere soddisfatti. Il desiderio di conoscenza, già individuato da Aristotele come costitutivo dell’uomo (fin dalle forme elementari del mero bisogno di percepire e della più rozza curiosità) sembra collocarsi in posizione mediana. Probabilmente è subordinato al desiderio di dominio, al quale è congiunto per la convinzione, più o meno consapevole (e comunque radicata nell’esperienza infantile) che sapere sia potere. Il potere, infine, è una delle dimensioni più opache e potenti della dimensione umana. Mi pare strettamente congiunto con l’angoscia di morte, perché rimanda sempre al bisogno di rappresentazione nell’altrui coscienza.
Per questo potere non è semplice facoltà di disporre degli altri, ma efficacia nel colonizzare la coscienza degli altri. Il che lo rende la più fragile delle acquisizioni umane, perché, come osservava Aristotele nell’Etica Nicomachea a proposito della fama, consegna la felicità nelle mani di coloro che la tributano. Non vi sarebbe nulla di gratificante nel disporre dell’altrui esistenza se non assumessimo per congettura che ciò ci procura una sorta di accesso preferenziale e dominante all’altrui coscienza e rappresentazione. Il potere esercitato su automi umanoidi non avrebbe nulla di paragonabile a quello esercitato su uomini. Vale a dire su coscienze. In che modo questa colonizzazione delle altrui coscienze esorcizzi l’angoscia di morte è l’ultimo interrogativo al quale che questo esplorazione minima della cupiditas conduce.
Seguendo il filo della riflessione agostiniana, l’esorcismo consisterebbe in una sorta di desiderio anticipatore: nel suo fondo, infatti, la cupiditas è brama del nulla, presentificazione, quindi, dell’impresentabile, tratteggio dell’irrappresentabile, incontro con l’altrove assoluto: nella coscienza dell'altro si realizza l'infantile desiderio di farla in barba al nulla. Quando verrà a cercarci, non saremo laddove saremo cercati.
Della montagna si è reduci. Se la si frequenta o la si sfida ad un certo livello. È una specie di sindrome, poco studiata, simile a quella dei reduci dalla guerra, o degli scampati da un incidente aereo. Tutto il resto è banale. È così difficile adattarsi allo scorrere insignificante della quotidianità, così opaca, così ottusa, così piatta. Magari pensare che alla fine sarà un letto di ospedale il sostegno negli ultimi istanti della vita. Un letto d’ospedale!

Sursum corda: in alto i cuori. La montagna favorisce meditazioni religiose. Ne propongo una, che mi sta molto a cuore. Perché non prendere davvero sul serio la fede nel Dio che è padre? Possiamo davvero credere questo, e concepire che Dio sia persona che in qualche modo possa essere offesa? Quale padre potrebbe mai ricevere da un figlio che ama sopra ogni altra cosa un’offesa? A meno che con questa parola si voglia intendere, secondo l’etimo, una ferita. Un dolore, questo sì, un dolore infinito. Non dovremmo anche pensare che Dio attende da noi una consolazione, per l’infinita afflizione che lo trafigge, di fronte ai figli che vede perdersi negli inferni che è penoso solo nominare? Per l’afflizione che lo trafigge al pensiero che questi inferni sono filiazione di quella realtà sublime ed orribile insieme che è la libertà di cui ha voluto dotare l’uomo?
Non vogliamo anche consolare Dio, ed in questo consolarci per avere davvero un padre?
Se questo è il volto di Dio, è davvero difficile poterlo sentire come giudice. Quanto all’inferno, per un elementare principio di sussidiarietà, neppure se volesse Dio avrebbe bisogno di metterci mano: gli uomini sono bravissimi a costruirselo da sè. Ed alla fine in Dio risuona lo strazio della creatura che avverte quanto poco basterebbe per porre fine al dolore, quanto poco, in atteggiamenti, in gesti, in parole. Quanto poco basterebbe per dissipare il dolore più profondo. Quanto poco. Poco come certi sogni intrisi di luce, in cui tutto risplende, pacificato. Poco quanto un passo che non riusciamo a fare, ammaliati dal vuoto che crediamo ci ghermirà, se non tratterremo il piede.

Solo la montagna regala l'esperienza dello sguardo d'insieme. Dalle vette è questo ciò che accade e la panoramicità è un elemento essenziale del loro pregio. Proprio pensando a questa esperienza mi azzardo a scrivere quel che segue. Nientemeno che un tentativo di indovinare quale sia la tonalità di fondo del nostro tempo. Una tonalità fortemente consonante con lo stoicismo antico.
Argomentazione.
I.
Nel pensiero storico si afferma l’onnipotenza del Logos-Ragione che pervade senza residui e fin nei dettagli minimi tutto ciò che è e tutto ciò che accade. Ma questo Logos-Ragione è imperscrutabile per la comune ragione umana: solo il saggio, più raro dei parti di una mula, lo può comprendere. Il che, forse, ha forte consonanza con il diffuso sentire che avverte da una parte la sussistenza di una qualche ragione di fondo dell’intera realtà (del resto gli scienziati hanno sostituito i sacerdoti come ministri della verità tout court, e la scienza è per definizione scommessa sull’applicabilità delle categorie a diverso titolo logiche – es. della matematica – alla realtà); dall’altra, però, avverte una sempre maggiore opacità sul senso di questa ragione, che appare oltre-umana, quando non dis-umana (non sarà un caso che al vertice di popolarità e citabilità filosofica si ponga oggi Nietzsche, enfatico araldo della morte di Dio, cioè della sempre maggiore credibilità di ogni ipotesi di significato che sia in qualche modo intrinseco alla realtà).
II.
Nella filosofia stoica il destino riserva ad ogni uomo una parte da recitare nella rappresentazione della propria vita; compito e dovere dell’uomo è recitarla al meglio, secondo la logica del proprio ruolo. Il che mi pare esprimere molto bene la convinzione quasi imperante che, alla fin fine, ciascuno non solo abbia un ruolo, ma debba interpretare questo ruolo, come viene espresso in molti modi di dire (fare il proprio mestiere, essere professionali, essere un buon...): questo è il fondamento etico ultimo dei contemporanei orfani di Dio, ed alla fin fine tutto si riduce ad essere buoni professionisti della propria esistenza (mi viene in mente anche la categoria dell’esistenza etica tratteggiato da Kierkegaard).
III.
L’etica stoica è un’etica desolante, quasi disperata: non c’è gioia, perché la dimensione stessa della gioia è sotto il segno dell’imperativo ad essere ciò che si deve essere. La felicità è il deserto delle passioni, l’integrale accettazione di ciò che è, come proprio invalicabile destino. Ad un primo sguardo il nostro tempo parrebbe, invece, segnato dal culto sistematico delle emozioni. In realtà, però, non vi è niente di più depressivo della gioia di vivere (qualunque cosa possa essere) dell’universale doverosità di godimento, spensieratezza, leggerezza. L’immagine stessa del cosmo stoico, così singolare, così terribile, è una sorta di metafora dell’esistenza contemporanea: un tutto in sé compiuto e finito, circondato da un vuoto infinito, quasi annegato ed annichilito in esso.
IV.
Alla fin fine nella realtà pensata dagli Stoici, interamente permeata dal Logos, non vi è differenza di valore se non nella differente tensione del logos: l’etica stoica è, davvero, nell’universale campionario della forza e della debolezza, l’etica del tónos, della tensione, per cui bene è tensione e male allentamento. La contemporanea (ma non solo) ossessione per l’essere tonici, sodi, tesi, nella propria corporeità, avrà a che fare qualcosa con questo?
V.
Gli Stoici pare siano stati gli unici ad affermare la totale compenetrazione dei corpi, per cui il principio attivo, il Logos-Fuoco, ed il Principio Passivo (ovvero to poioùn, l’agente, e to pàschon, il paziente) sono indissolubilmente compenetrati. Raggelante metafora del tragico intreccio fra bene e male, carnefice e vittima, colpa ed innocenza, corpo e spirito di cui è disperata e disperante espressione molta parte di ciò che diciamo la nostra cultura e la nostra storia.
VI.
La concezione stoica del tempo lo rappresenta come un circolo: la vicenda dell’universo ha un suo inizio, un suo svolgimento ed una sua fine, l’ekpyrosis, l’immane rogo finale nel quale ogni cosa sarà consumata dal e nel Fuoco-Logos. Da esso, però, ogni cosa sarà di nuovo generata, tutto riaccadrà identico a se stesso, di nuovo vivrà Socrate, di nuovo sarà condannato e berrà la cicuta, e così per ogni minimo dettaglio dell’essere e dell’accadere, perché ogni cosa sarà esattamente e per sempre, nel susseguirsi infinito dei cicli, quel che deve essere. Il che significa, a ben vedere, che il tempo non è svolgimento, sviluppo, ma piuttosto la successione di istanti ciascuno dei quali è eterno, perché eternamente fu, è e sarà. Nella contemporanea sarabanda della leggerezza l’istante viene vissuto proprio come se fosse eterno: il che, come già Nietzsche intuì nella dottrina dell’eterno ritorno dell’eguale, può essere la disperazione più profonda o la più inebriante gioia (o forse qualcosa che oscilla fra l’una e l’altra cosa).
VII. Last but not least, gli stoici affermano, forse primi nella cultura antica, il cosmopolitismo, perché il saggio si sente cittadino del mondo, ed insieme affermano che le differenze di condizione sociale, povertà, ricchezza, libertà, schiavitù non sono per natura, ma discendono dalla malvagità umana. Nel contempo, però, affermano l'insuperabilità di questa malvagità e quindi delle differenze e dell'articolazione stessa del mondo in popoli e culture differenti, per cui, alla fin fine, ciascuno dovrà saper essere buon romano, buono schiavo, buon senatore. Tutto ciò assomiglia molto alla contraddizione del nostro tempo, che afferma il valore dell'eguaglianza ma, nel concreto, legittima differenze sempre più profonde nelle condizioni economiche e nelle opportunità effettive, appellandosi all'ineluttabilità delle leggi dell'economia e del mercato, che sono, forse, l'ultima metamorfosi dell'imperscrutabile ed onnipotente Logos stoico. Così come, infine, la raggelante giustificazione stoica del male, condizione necessaria perché il bene possa essere, assomiglia parecchio alla tragica resa del nostro tempo all'ineluttabilità del male.
Nessun rimbrotto dalla filosofia. Solo un sorriso un po’ amaro. Ecco un ennesimo (mediocre) filosofo, sembra voler dire, ansioso di scoprire il fondo delle cose, di quel che abbiamo in sorte e di quel che siamo. Del resto la convalescente matrona porta nel cuore l’antica sentenza platonica: solo chi sa cogliere con sguardo d’insieme il tutto (panoptikós) è filosofo. Ma nel contempo sa che grande è la menzogna del cuore.
Non ho animo di farlo capire, considerata la sua convalescenza, ma una cosa mi è sempre parsa insopportabile della filosofia: troppo spesso ha replicato l’indegna inclinazione dell’uomo ad essere forte con i deboli e debole con i forti. Dopo la diaspora dei saperi scientifici, per lungo percorso custoditi entro il suo ampio alveo, si è dovuta scontrare con la frustrante esperienza di vederli sempre più crescere. E, come accade per i figli, quanto più crescono, tanto meno li si capisce. Oggi la filosofia elabora il lutto dell’impossibilità di comprendere davvero, nella loro sempre maggiore articolazione e complessità, le scienze: un filosofo può ragionevolmente, al più, cercare di tenere il passo di una scienza, non senza crescente fatica. Pare inesorabilmente tramontato il tempo in cui la filosofia teneva sotto la sua tutela i figli già grandicelli, proponendosi come filosofia di… Lo scienziato si sente sempre più legittimato, in virtù dell’effettiva conoscenza dello status quaestionis del proprio campo di ricerca, ad essere l’unico attendibile filosofo del proprio sapere. L’obiezione che la filosofia dovrebbe pur sempre rimanere il luogo nel quale si sondano gli statuti epistemologici delle scienze vale sempre meno: questi statuti non sono statuiti una volta per sempre, piuttosto sempre più risentono dello storico ed effettuale farsi della ricerca scientifica.
La filosofia sconta questa debolezza offrendosi come il luogo in cui in qualche modo i saperi possono convergere, o quantomeno dialogare: nei suoi manuali non mancano ampi (anche se non sempre puntuali) riferimenti alle scienze matematiche, logiche, naturali, politiche ed economiche.
Salvo poi rivalersi, stizzita, su quegli ambiti della cultura che ritiene in qualche modo ancora alla portata della sua comprensione effettiva, e quindi (anche se non lo ammetterà mai), più deboli. Letterati, musicisti, pittori: di queste figure di pensatori si trova scarsissima traccia nei manuali. Leopardi non vale un filosofo di media statura dell’Ottocento, anzi, non ne vale nessuno, stando alla logica manualistica.
La filosofia, accanto a me, protesta che la logica manualistica non è la logica dei filosofi. Mi pare una protesta un po’ debole (uso malignamente questa dimensione valutativa oggi così in uso fra i filosofia, che parlano, senza avvertirne l’involontario e comico rimando all’infanzia, di forte e debole, perché ogni altra categoria valutativa che abbia un’articolazione minimamente più “evoluta” pare a loro bruciata, logora, impraticabile). Forte, invece, è la replica che mi esce quasi di getto: non c'è di che inquietarsi se le scienze son sempre più inaccessibili, resta il mondo delle parole, appannaggio inalienabile di letterati e filosofi. Ma non dovrei essere così cattivo con un'anziana matrona convalescente.

DI QUEL CHE SI TROVA SENZA CERCARE
Serendipity è un bel concetto inglese (introdotto a metà settecento dallo scrittore Horace Walpole) che ben si adatta ad uno degli aspetti più affascinanti del camminare per monti. Significa cercare qualcosa e trovare, per caso, qualcos’altro, più importante ed interessante. Molte delle più importanti scoperte scientifiche sono avvenute così. Ma, tornando alla meno essenziale attività di consumar scarpe per monti, accade non di rado che quanto si incontra e si vive sia sorprendentemente più interessante di quanto si cercava o ci si aspettava. Talvolta si tratta di incontri con persone, altre volte con animali, o anche scorci, giochi di luce, prospettive, suoni, profumi. Solo eccezionalmente accadrà che l’intero nostro modo di guardare al mondo ed all’esistenza ne risulti mutato. E tuttavia qualche prezioso ed inatteso tesoro lo potremo serbare gelosamente fra le cose di maggior valore.
(Quasi) un corollario.
Fra i tanti effetti della miopia filosofica (della miopia della filosofia, non in filosofia) vi è una netta sopravvalutazione dell’attitudine dell’uomo al pensiero. Per questa sopravvalutazione si crede che la scoperta segua ad una ricerca. Ma, in questo caso, è spesso la madre ad essere ignota, mentre il padre è certo: il caso.
L’uomo ha imparato anche a volare, ma ciò non significa che sia nativamente atto al volo. Similmente, il fatto che gli uomini siano riusciti a pensare, ad elaborare concetti, a lavorare con idee, non significa che ciò appartenga ad una sorta di loro vocazione originaria. Prova ciò, penso (?), l’assenza di correlazione significativa fra la qualità degli uomini e quella delle loro idee. Le idee migliori sembrano, anzi, legate da una sorta di affinità elettiva che le lega agli individui peggiori (il grande inquisitore difendeva l’evangelo). E, per soprammercato, vale anche il simmetrico. Insomma, la famigliarità al pensiero per l’uomo è simile a quella al nuoto per il montanaro.
Di più: il commercio degli uomini con le idee finisce (in)fallibilmente per adulterarle. A questo i filosofi avrebbero dovuto prestare ben maggiore attenzione, domandandosi: di quali possibili (e spesso pericolose) degenerazioni sarà passibile la mia dottrina? Ma la malattia cronica della filosofia è quella di soggiacere al fascino di una forma particolare di sineddoche, scambiando la parte per il tutto: essa scambia, infatti, l’avvedutezza critica (quando c’è) del filosofo come avvedutezza critica dell’uomo in generale. È ben vero che molti filosofi hanno espresso l’esigenza di preservare la filosofia dalla contaminazione dei profani, ma tutto ciò è rimasta affermazione di superficie, perché solo raramente nell’esercizio della filosofia si è fatto valere il principio di precauzione, cioè, di nuovo, la domanda: a quali fraintendimenti mi espongo? Forse perché è davvero imprevedibile la multiforme varietà di questi fraintendimenti.
La triste morale di tutto ciò è che l’incomprensione è la regola. Nel pensiero. E non solo.
Alla scuola della montagna la filosofia dovrebbe, dunque, apprendere un'antica virtù ben nota a quanti sono costretti a vivere della montagna e delle sue angustie: la prudenza.

Fra le virtù dell’uomo scavato dalla disciplina inesorabile della montagna spicca, come detto, la prudenza. Lo stesso, parrebbe ad un primo sguardo, non vale per l’ironia. A meno che la intendiamo come arguzia: questa si trova, qua e là, in forme particolarmente felici e sferzanti.
Parlo, qui, invece, dell’ironia come distacco di sé da sé. Distacco salutare per ammansire la naturale ferocia e stupidità dell’uomo. Distacco che mitiga l’imprevedibile pericolosità di chi si prende, come si suol dire, troppo sul serio. Distacco che non è facile affettazione, ma una sorta di ravvedimento (operoso?) dell’io dalla sua innata tendenza ad allagare la realtà delle sue idiosincrasie e chimere.
L’ironia è sguardo tenacemente e dolorosamente abbarbicato alla realtà, come lo sguardo dell’uomo di montagna, per costrizione, deve essere. Crede ancora che la realtà ci sia, al di là della caligine del linguaggio e della trama dell’universale interpretazione, crede ancora che questa realtà sia sempre più articolata e multiforme di quel che al nostro pensiero riesce di figurarsela.
L’ironia è distacco di sé dall'impudente invadenza del sé. L'ironia è, dunque, pudore, quel modo d'essere così radicato nel sentire della gente di montagna.

HANGING ROCK ED ALTRI MISTERI DI PIETRA
Fra gli oggetti più singolari del panorama montano stanno senza dubbio le rocce o i massi sporgenti, incombenti, sospesi, in equilibrio precario, che paiono lì lì per cadere. In inglese “hanging rock”. Qualcuno ricorderà il film “Picnic ad Hanging Rock” del regista australiano Peter Weir (1975), a sua volta ispirato all’omonimo romanzo di Joan Lindsay (1967). Il titolo è tratto, appunto, dalla località australiana di Hanging Rock, straordinario complesso di guglie e torri rocciose di elevazione non eccezionale (poco più di cento metri), ma dalle prepotenti forme verticali ed enigmatiche. L’antichità della formazione (un milione di anni, anche se in Australia ve ne sono altre che risalgono a trecento milioni di anni fa) e la forte attività magnetica (legata probabilmente all’origine magmatica della formazione), unite alla conformazione labirintica ed alle tracce di interventi umani (iscrizioni, cavità, allineamenti che richiamano la più nota Stonhenge), ne fanno un luogo denso di suggestione e mistero.
Romanzo e film si ispirano ad un fatto realmente accaduto il 14 febbraio 1900 (ma non ne è mai stata trovata traccia su giornali dell’epoca o nell’archivio di polizia, per cui è probabile che tutto rimandi alla fantasia letteraria della scrittrice): tre ragazze ed un’insegnante dell’Istituto di Appleyard scompaiono durante un’escursione pomeridiana nel cuore del complesso di rocce. Solo una viene ritrovata, in stato confusionale, e non sa, né saprà mai, dare alcuna indicazione su quanto accaduto. Questo è solo il principale di una serie di misteri legati al romanzo, che venne pubblicato, per volontà dell’editore, privo del conclusivo capitolo XVIII, nel quale veniva riportata la soluzione (si fa per dire) dell’enigma (le poche pagine di questo capitolo sono state di recente tradotte e esse a disposizione sul web da Roberto Mengoni).
Prima di tornare su questo mistero, facciamo qualche passo indietro. Uno spuntone di roccia nei pressi della riva del lago di Silvaplana, lungo la quale Nietzsche amava passeggiare nei lunghi pomeriggi estivi, portò alla sua più famosa intuizione, quella dell’eterno ritorno dell’identico. Tutto torna eternamente, ogni singolo istante eternamente riaccade, identico, in ogni suo aspetto. Nietzsche diede anche veste razionale a questa intuizione (non era certo un banale irrazionalista spregiatore della scienza, come talora lo si dipinge): nell’eternità del tempo, ogni combinazione di elementi, anche la più improbabile, accade un numero infinito di volte. Per dirla con un esempio banale: una scimmia che batta a caso su una tastiera per un tempo infinito dovrà, per il calcolo delle probabilità, comporre infinite Odissee, ed Iliadi, ed anche testi come quello che ora affligge il povero lettore che consuma la retina sul monitor del computer.
Ma se tutto torna eternamente, identico a se stesso, ogni istante non solo riaccadrà infinite altre volte, ma è già accaduto infinite altre volte. Il che equivale a dire che ogni istante è eterno, non ha senso dire che accada prima piuttosto che poi. Il tema, dunque, è quello dell’eternità dell’attimo, che risulta sciolto dalla catena temporale del prima e del poi.
Ora, al di là della dimostrazione razionale, che potrà apparire più o meno persuasiva (certo addentrarsi nell’aspro terreno dell’infinito senza sofisticati strumenti matematici è molto pericoloso…), la teoria dell’eterno ritorno o dell’eternità dell’attimo è espressione di un vissuto, di un’esperienza fortissima e rivelatrice. Capita che certi istanti siano carichi di una tale intensità da scardinare il tempo: è come se il loro da che cosa e verso che cosa svanisse, come se fossero sospesi in una dimensione sottratta al divenire, come se fossero, semplicemente, senz’altro. Esperienze di questo genere non sono rare di fronte a scenari montani: l’hanging rock sempre suscitarle in modo particolare.
Ed in effetti la risoluzione dell’enigma della scomparsa delle studentesse Miramda e Marion e dell’insegnante (di matematica, manco a dirlo) miss Ward, contenuta nel citato capitolo XVIII di “Picnic ad Hanging Rock” si colloca in questa prospettiva di sospensione del tempo. Ne cito solo il brano iniziale: “Sta accadendo adesso… La scena non cambierà mai, neppure per la caduta di una foglia o il volo di un uccello.” Ometto quel che si rivela poi in questa dimensione di sospensione, della forza e nitidezza di ogni singola percezione, della manifestazione della perfezione di ogni singolo dettaglio dell’essere, delle metamorfosi della vita, del mistero che unisce e separa i regni della luce e dell’oscura terra, e di molte altre cose che sconfinano nell’esoterismo. Quel che mi interessa è rilevare ancora l’accostamento fra la roccia sospesa e l’esperienza della sospensione del tempo. Meglio, dell’illusorietà del tempo. La roccia che pare dover cadere ma non cade suggerisce proprio questo: un divenire che è fissato per sempre, che in realtà, appunto, non diviene.
Capisco di essere finito in un ginepraio (un po’ come quelle macchie di ontani che in montagna sono l’afflizione dell’escursionista) nel quale non è facile districarsi. Ma, certo, per chi ha sentito questa dissolvenza del tempo, magari nel nietzschiano grande meriggio (quando tutto è fermo nella luce meridiana), non si tratta solo di una macchia di intricati concetti o astruserie. Si tratta di un vissuto tanto forte da non lasciare indifferenti. Un vissuto che forse ci consegna domande, forse no. Certo è che la gioia profonda legata a questo vissuto è ben espressa dalla frase di una ragazza del college: “Abbiamo milioni di anni tutti per noi!”Tutto, dunque, sembra avere il suo rovescio, ed il tempo si può rovesciare nell’eterno. Se così è, anche il fascino magnetico dell’hanging rock deve avere un simmetrico-contrario. Vero: non è difficile trovarlo nelle escursioni montane. In molto alpeggi si vedono, infatti, roccioni aggettanti adattati alla meglio alla funzione di miserrimi ricoveri per pastori e greggi (fra i più celebri, quello che accoglie l’escursionista che dai Bagni sale alla capanna Omio, appena fuori dalla fascia boscosa). Sono i cosiddetti “càmer” (termine che significa “luogo riparato”), la versione prosaica e triste dell’hanging rock. Qui nessuna suggestione di mistero accende la fantasia, ma solo un senso profondissimo di desolazione e quasi di mortificazione al pensiero di quanto dovessero essere dure le condizioni di vita di chi passava la stagione estiva in alpeggio, soprattutto all’infuriare di violenti temporali. Qui il tempo non è sospeso, ma piuttosto rattrappito, dolorosamente ripiegato su se stesso come il corpo che si abbandona al ristoro del sonno sulla fredda terra. Nessun profumo d’eterno, qui. Solo l’odore un po’ stantio della povertà.Parente dell’hanging rock è il masso erratico, sceso non si sa quando, talora neppure bene da dove e piantato in una collocazione talvolta semplicemente sorprendente. Anche qui, dunque, l’immaginazione ha di che lavorare. Nel citato racconto della Linsday compare anche un misterioso monolito, che sormonta i roccioni e sembra la chiave di volta dell’intero mistero. In questo caso alle suggestioni letterarie si affiancano le credenze popolari, che immaginano antiche popolazioni di giganti che disseminarono qua e là questi massi per un qualche loro misterioso scopo, esseri malefici come streghe che, durante le alluvioni, spingerebbero enormi massi verso i centri abitati, o anche uova depositate da draghi nei tempi remoti in cui ancora volavano alti sulle valli alpine (tali sarebbero i massi di forma ovoidale, posti in posizioni curiose).
Il masso erratico è sempre stato scrutato con grande attenzione dallo sguardo dei montanari. Scrutato di fino, intendo. A questo sguardo rivela una scrittura multiforme ed arcana. Segni, orme, impronte, caratteri difficili da interpretare. L’esegesi, dunque, resta libera e segue la via più facile, quella della paura: ecco, allora, zoccoli del diavolo e dita di streghe. Ma anche, per necessario contrappeso, orme di santi, chiavi di San Pietro, et similia.
Il mistero di questi massi è dunque poliedrico: perché stanno dove stanno? Di cosa parlano? Cosa racchiudono al loro interno? L’impressione di questi curiosi personaggi del panorama montano ci strappa prepotentemente dal presente: per un lato siamo proiettati in un remoto passato, tempo di draghi e giganti; per un altro, siamo proiettati verso un futuro altrettanto remoto, nel quale, immaginiamo, la verità di questi massi, il loro perché, verrà svelato in virtù di una qualche magica metamorfosi. Noi stiamo nel mezzo, nel tempo in cui nulla più, o ancora, avviene.La trilogia dei misteri nella pietra potrebbe essere degnamente chiusa dagli “om”, gli ometti, manufatto sicuramente umano, anch’esso, però, spesso perso in un tempo remoto. Se escludiamo, infatti, i più recenti ometti con evidente funzione di segnavia (ometti modesti, appena accennati) e consideriamo quelle torri di sassi che qualche volta sono alte poco meno di un essere umano, allora la fantasia ritrova terreno da arare. La collocazione suggerisce spesso una funzione (segnalazione di punti topici, assai utile in caso di scarsa visibilità – soglia di burroni, partenza di sentieri, sommità di dossi). A volte, però, si ha l’impressione di una sorta di funzione accessoria, forse rituale, come se il luogo marcato avesse una valenza non semplicemente orientativa. Di più non si saprebbe dire. Alla fine, l’impressione che resta è che il linguaggio della roccia rivela una vitalità inattesa, considerato che, nella rappresentazione comune, essa è prevalentemente associate a mera saldezza, durezza, assenza di vita.
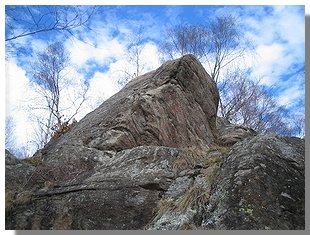
Il sociologo Zygmunt Baumann ha felicemente lanciato la metafora della società liquida, a significare la società contemporanea che, a differenza del passato, nel suo convulso vortice produttivistico, globalistico e consumistico, non è più in grado di passaggio allo stato solido, cioè ci costringe a fluttuare in una dimensione priva di un “ubi consistam”, di ancoraggio a punti di riferimento solidi che traccino le coordinate di un quadro di valori davvero interiorizzabile. Si tratta di una delle tante varianti della diagnosi del male oscuro del presente, già profetizzato da Nietzsche nell’annuncio della morte di Dio: viene meno ogni riferimento assoluto, tutto fluttua, senza centro, senza periferia, senza riferimenti che oltrepassino un asfittico orizzonte temporale.
È, questo, un modo possibile per intendere la valenza semantica dell’acqua: un ambiente indifferenziato, come un fondale marino, dove tutto è omogeneo. Un modo che si accosta ad un altro più antico, legato alla purezza, alla vita ed alla rigenerazione.
A ben osservare l’universo montano, si scorge un terzo scenario: l’acqua è signora. Indiscussa, incontrastata. Ad essa si deve la vita, ma la sua potenza plasma pressoché tutti gli aspetti di tale scenario. L’acqua disgrega e modella, assegna nei millenni la stessa ripartizione di valli e convalli, tutto decide, tutto dispone. A dispetto delle sue sembianze spesso inoffensive ed innocenti. Potente e prepotente, l’acqua raggiunge ogni anfratto. Nulla le sfugge. Vivente e non vivente sono ai suoi piedi. La montagna è la vera società liquida.
L'acqua è, dunque, l'icona della potenza. Non, però, del potere, cui si addice piuttosto un'immagine che renda la sua natura di assoluta viscosità. L'acqua travolge, scava, rimodella. Il potere frena, soffoca, trattiene. Un po' quel che si immagina parlando di muro di gomma. Che però rende l'idea un po' fasulla del rimbalzare, piuttosto che quella, più reale, dell'essere invischiati, avviluppati, amministrati, anche, dall'ottusità, dall'opacità, dalla pervicacia, dall'abitudine.
La potenza costringe ad assumere una forma che non è la propria; il potere soffoca quel libero movimento che è l'assumere la propria forma. Una buona esperienza di montagna insegna, io penso, a temere l'uno e l'altra, a rifuggire da ciò che potrebbe liquidarci e liquefarci.

Le cronache estive riportano non di rado episodi di recupero, con l’elisoccorso, di escursionisti o cercatori di funghi stremati da sforzi del tutto sproporzionati rispetto alla loro effettiva preparazione fisica. Casi limite, si dirà. Però spesso i casi limite sono rivelatori di una distorsione che ben si mimetizza fin nelle pieghe banali della quotidianità. Distorsione, ho detto, ma il termine non è quello più felice. È una specie di febbre, di sudditanza ad un imperativo categorico che è ben radicato nella cultura occidentale. Si ricorda Aristotele per aver definito l’uomo animale fornito di ragione, ed anche animale “politico”, cioè per natura portato ad associarsi ai suoi simili. Nell’Etica Nicomachea egli definì, però, l’uomo come “ergon”, azione. Nella teologia cristiana, l’ignavia o accidia è collocata, come vizio capitale, accanto ad ira, invidia, sussuria, superbia e gola. Molti secoli dopo Hobbes affermò che la pena della carcerazione è legata alla consapevolezza che la massima afflizione per l’uomo è essere privato della possibilità di agire. Ed ancora, nel poema omonimo di Goethe Faust traduce il celebre incipit del Vangelo di Giovanni, “In principio era il Logos”, con “In principio era l’Azione”. Schopenhauer, infine, individua nella noia che assedia l’uomo privo di azione e di preoccupazione la massima dimensione della sofferenza.
Questa concezione antropologica ci circonda come l’aria che respiriamo, per cui ci manca il necessario distacco per avvertirne gli aspetti addirittura grotteschi. Fare sempre, piuttosto che non fare, ma anche aspirare sempre, piuttosto che non aspirare, addirittura desiderare sempre, piuttosto che non desiderare. Desiderare il desiderio, come si è detto, avvertire come angosciante la prospettiva del congedo (perché prima o poi essi prendono congedo dalla nostra esistenza) di aspirazioni e desideri. Lo stesso piacere viene nominato entro questa dimensione: “performance”, si dice, come se non vi fosse un piacere non assimilabile ad un fare.
Questo sentimento della vita (perché per noi questo è vita: l’inerzia non merita cittadinanza nella dimensione del vivere) da un lato spiega perché la cultura e la storia dell’occidente si siano affermata come “la” cultura “la” storia, dall’altro, è la radice dei più inquietanti aspetti che oggi ci inducono ad un ripensamento di alcuni suoi aspetti di fondo.
Fare, sempre, piuttosto che non fare. Già Pascal intuiva che all’uomo sarebbe risparmiata gran parte della propria infelicità se solo sapesse starsene fermo a non far nulla in una stanza. Il che si riscontra anche in molti frangenti della nostra quotidianità: quanti guai ed affanni ci verrebbero risparmiati se, in diverse circostanze, sapessimo semplicemente oziare, astenerci dal fare. Ma l’ozio è una delle dimensioni esistenziali più diffamate nella nostra cultura. Gli si imputa la paternità dei vizi, senza considerare che è proprio per l’incapacità di oziare che si diventa viziosi (i vizi sono faticosi, il gioco della pena che ci si deve dare per soddisfarli ed ancor più delle conseguenze che ne subiamo non vale la candela della gratificazione che ne traiamo).
Questa furia cieca del fare viene trasposta anche nell’esperienza che per lo più si consuma della montagna. Montagna, dunque ascensione, escursione, quantomeno passeggiata. O, se proprio si vuol stare fermi, qualcosa si deve pur fare: “prendere” il sole. Eppure la montagna è uno dei luoghi più propizi per l’ozio. Regala angoli nei quali semplicemente si può stare a guardare gli arabeschi di una parete rocciosa, le mutevoli bizzarrie delle nubi in cielo, i profili ondeggianti di fronde, erbe e fiori ed i giochi di luce che il sole vi intrattiene. E poi ascoltare la voce del vento, il canto di insetti ed uccelli. Ed ancora, avvertire odori e profumi, probabilmente la più forte delle sensazioni, che allude ad una felicità senza nome.
Quando Adorno, nei Minima Moralia, immagina di dove rispondere alla domanda su quale sia, in definitiva, la configurazione della felicità in un mondo redento, risponde che null’altro sapremmo rispondere, se non stare ad oziare, non far nulla, come le bestie. Con il tramonto di una vita contadina scandita da improba fatica sono andati scomparendo anche i montanari maestri di ozio (la stanchezza estrema può educarci alla profonda saggezza del semplice far nulla). Restano le bestie, in montagna (e non solo) ad offrire edificanti esempi.
Se solo l’uomo, nella sua alterigia, non pensasse di non aver nulla da imparare dalle bestie.
Se solo l’uomo non avesse un vuoto incolmabile da colmare. Ma questo pensiero ci riporta sugli oscuri sentieri dell’angoscia del vuoto.
Perché la filosofia non si senta troppo spaesata in montagna, occorrerà proporle qualche tema con il quale abbia antica frequentazione e confidenza. Tale è la riflessione sui rapporti fra natura e cultura. Tema non solo filosofico, m anche psicologico, sociologico, antropologico e più generalmente culturale. Sì, perché la cultura gioca sporco: in sé e da sé istituisce il confronto.
La montagna offre molteplici situazioni che permettono di riflettere. Detto nei termini più semplici, si tratta anzitutto (perché questo è il primo livello di riflessione) di distinguere ciò che è frutto dell’operosità umana (cultura) e ciò che non lo è (la natura). Per un consumascarpe questa distinzione è tutt’altro che esercizio di oziosa curiosità: quante volte capita di dover seguire od inseguire sentieri incerti (magari gli Holzwege di heideggeriana memoria – tale è il titolo di un celebre saggio di Heidegger – i sentieri che si perdono, che non portano da nessuna parte). Ed allora l’occhio, anche da una certa distanza, cerca di stanare il segno, la traccia, appunto, quell’esile filo di cultura che interrompe la natura (che poi spesso neppure è tale, perché è pascolo strappato al bosco da chissà quanto). Spesso lo vediamo, o crediamo di vederlo. Ma che altro è, a ben vedere, se non un surplus di regolarità rispetto a quell’oscillante congerie sempre sospesa fra regolarità e caos che è propriamente ogni lembo dell’ambiente naturale? Un surplus di regolarità che si lascia scovare da pochi indizi, il filo regolare della piega della cotica erbosa o la ferita che lascia scoperta la scura terra. Un tempo si tracciavano non di rado semplici incipit di sentieri, come dire: prosegui in questa direzione. O anche, il sentiero lo si tracciava solo all’ingresso del bosco, in modo tale che solo chi conoscesse i luoghi lo potesse trovare a colpo sicuro. Il consumascarpe sa che certi sentieri partono timidi ed incerti, e poi si fanno larghi e baldanzosi.
Ed ancora, su natura e cultura: i segnavia. Oggi sono bolli di vernice. Un tempo si ricorreva agli ometti, da quelli appena abbozzati (due sassi sovrapposti soltanto su un largo masso a fungere da base, o un sasso a forma di lancia trattenuto in posizione verticale da altri sassi sul terreno) a quelli imponenti e sontuosi, di dimensioni che imitano quelle umane e quindi visibili da grandi distanze. Se volessimo definire l’ometto, potremmo dire che è una configurazione di massi che solo con estrema improbabilità può essere frutto di forze naturali. E come tale viene immediatamente riconosciuto dall’occhio umano. La natura ha un suo ordine: l’uomo vi istituisce un ordine proprio, e raramente fallisce nel ritrovarlo.
Qualche volta la cosa funziona come una specie di gioco: l’occhio cerca la cultura mimetizzata fra le pieghe della natura. Il caso più istruttivo è quello dei disegni che la natura traccia sui grandi massi. Come da sempre l’uomo ha cercato nella configurazione delle stelle disegni che richiamassero la più familiare dimensione della propria cultura e dei propri simboli, così, in dimensione più modesta, i grandi massi sono stati vagliati per cercare segni dell’umano e del suo universo culturale e religioso. Ecco emergere, fra i moltissimi sghiribizzi senza senso della natura, impronte di santi, angeli, streghe e diavoli, chiavi di San Pietro e quant’altro. Per non parlare delle incisioni che realmente sono state tracciate da mano umana.
Cosa significhi questa ricerca della cultura nella natura? Una rassicurazione? Una colonizzazione? Un gioco insondabile nella sua origine come buona parte dei giochi? Qualunque sia la risposta, è difficile sottovalutare la fascinazione che esso esercita sull’uomo. Si finisce spesso per vedere linguaggio ovunque, nel tramonto, nella voce del vento, nei profili delle vette montane, come se il senso di ogni cosa fosse quello di parlare all’uomo. Per questo mi pare un sano esercizio di sobrietà tornare (?) a vedere la montagna come uno scenario che nulla ha da dire, nulla da insegnare, ma solo, al più, qualcosa da suscitare (da noi stessi a noi stessi diciamo cose e diamo insegnamenti, mentre ciò che suscita non è linguaggio, ma, semmai qualcosa come un’origine incognita di tutto quel che può essere linguaggio).
Lasciamo sospesa la domanda, passando ad una diversa configurazione della riflessione sui rapporti fra cultura e natura. Su due versanti.
Innanzitutto un topos, un luogo comune: l’uomo devastatore della natura. L’essenza della cultura (almeno di quella occidentale) è stata autorevolmente individuata (da Heidegger, che in questo ha fatto scuola) come oblio, dimenticanza, notte nella quale si perde la differenza fra essere ed ente, ogni realtà è pensata come qualcosa che il pensiero può rendersi presente, catturare (concepire, secondo l’etimo) e manipolare secondo le proprie categorie. Questo il cuore della filosofia occidentale, di qui la scienza e la tecnologia che ne è l’inevitabile sviluppo, come progetto di manipolazione totale di tutto ciò che ricade nelle possibilità operative dell’uomo (quindi, anche, devastazione). Una versione filosoficamente più alta di un sentire abbastanza diffuso, secondo cui l’uomo sarebbe una sorta di peste che contamina e minaccia di uccidere il pianeta. Salvo poi pensare che la natura possa prendersi la sua rivincita sull’uomo stesso, reagendo alla sua azione devastatrice. Quel che un occhio discretamente attento può cogliere in montagna è però la complessità del problema, non riducibile a semplici slogan. Qui appare spesso chiaro che l’azione dell’uomo è (o, quantomeno, è stata) non devastatrice, ma ordinatrice. Senza la mano dell’uomo vi sarebbero maggiore caos, disordine o, come spesso si dice, dissesto. In passato, almeno, così era. Che poi oggi, in montagna come altrove, il pesante intervento dell’uomo sia perturbatore di equilibri difficilmente ricostituibili, è fin troppo ovvio. Ma a questo vorrei andare a parare: è difficile riassumere in una formula cosa sia stato, cosa sia e cosa possa essere l’uomo rispetto all’ambiente naturale nel quale vive. Ed è quantomeno curioso volerlo pensare come una sorta di deviazione maligna nello sviluppo degli esseri naturali. E se anche così fosse, allora sarebbe nella logica della natura o, se vogliamo, della vita, posto che una logica esista, che vi possa essere ospitato ciò che nega la vita. Ma qui mi fermerei: troppo oscura è la questione e troppo grande l’azzardo di voler stabilire ultimativamente quale sia il destino dell’uomo, quello della natura e cosa sia alla fin fine il nesso che li lega. Come un Giano bifronte, l’uomo è insieme ordinatore e devastatore, e la sua tecnologia può portare stravolgimento e salvezza. Uomo e natura, alla fine, sono una possibilità, di ferita e di balsamo.
Non meno oscuro il confronto-scontro uomo-natura se vogliamo tracciare la linea di confine non fuori dell’uomo, ma dentro l’uomo stesso. Ecco un grande fumo, anzi, per omaggiare la montagna, ecco una grande foschia. Cultura, conoscenza, cerebralità, ragione, da un lato; natura, emozioni, profumi, irrazionalità, fondo insondabile che cela gli intrecci fra psiche e biochimica del cervello, dall’altra. Quante discussioni, quanti dilemmi, quanti interrogativi sull’equilibrio, sugli intrecci, sui conflitti fra queste due dimensioni. L’impressione che ne ricavo è di un grande agglomerato di caotici corti circuiti, scorciatoie che il pensiero prende perché pensare non è meno faticoso che risalire ardue chine. E, come in montagna accade assai spesso, le scorciatoie portano smarrire la meta. Solo che in montagna ce ne accorgiamo, nel pensiero, per lo più, no. Mi pare, insomma, che buona parte delle linee di confine tracciate fra l’una e l’altra dimensione operino una scissione fittizia. Li chiamerei falsi bivi, come quelli che talora si incontrano su un sentiero: i due rami sembrano divergere, ma a volerli davvero percorrere senza fermarsi alla prima impressione si scopre che si ricongiungono.

In montagna l’eros parrebbe decisamente fuori posto. Altri contesti gli sono più congeniali.
Ovviamente un incipit del genere oggi è semplicemente demodè. Facilmente si indovina il possibile articolo di qualche rivista, che suonerebbe, più o meno: “Sesso in montagna: perché no?”. Ma, volendo restare fermi al luogo comune, dovremmo dire che un soggiorno montano conforta la filosofia nella sua antichissima diffidenza rispetto all’eros. Certo, in tempi recenti la frequentazione della riflessione filosofica con questa dimensione si è fatta meno rara e sporadica. Ma alla fine, forse per sano istinto, la filosofia più avveduta ha conservato un saggio distacco. Perché da sempre ha intuito che la sua natura è di rifuggire da ciò che per lo più si afferma e si crede, soprattutto se con ostinazione e pervicacia.
L’impero dell’eros è oggi impressionante, e così dovrebbe apparire, se solo lo si volesse guardare con un minimo di distacco. Si tratta di una sorta di porto franco, di koinè, di intesa larghissima: l'imperativo categorico è parlare dell’eros e praticarlo, sempre, comunque, quasi che senza di esso la vita fosse come un vecchio film in bianco e nero. Come l’eros sia riuscito a millantare la sua centralità nell’esistenza umana è difficile a comprendersi, e prima ancora a credersi. Affermare questo non significa riesumare antichi discorsi moralistici che mettono in guardia dai suoi pericoli: sessuofobia e sessuofagia (se è lecito coniare un nuovo termine che vorrebbe esprimere il consumo quasi alimentare dell’eros) sono piante che crescono da una medesima radice: l’intronizzazione dell’eros al centro dell’esistenza e delle rappresentazioni umane. Non a caso tutto un florilegio di metafore che alludono agli aspetti salienti dell’esistenza (successo, sconfitta, inganno, forza, debolezza, coraggio, noia, irritazione, esaltazione, euforia,…) è direttamente e sempre più largamente desunto dalle poche cose cui l’eros è connesso.
L’eros trionfa nella sua azione di imbonitore perché è riuscito ad associarsi ad un colossale corto circuito del pensiero (approfitto ancora per sottolineare che l’uomo sembra molto più idoneo per natura ad un sacco di altre cose piuttosto che a pensare): la sola allusione all’eros innesca una serie automatica di rappresentazioni condivise, di ammiccamenti, di luoghi comuni, anche da posizioni diverse. Il tutto rimanda ad un valore, sic et simpliciter: nei modi giusti (poi magari ci si divide anche fieramente su questa giustezza), l’eros è semplicemente purezza di valore. Come, semplicemente, il vivere. La sessualità è il motore immobile del desiderabile senz'altro: il desiderio, senza aggettivi, ad essa rimanda.
Un tempo l’allusione all’eros faceva scattare solitamente moniti, censure, inviti perentori a lasciare tutto in una dimensione di non esplicitazione; oggi le cose sembrano andare del tutto a rovescio, l’esplicitazione sembra essere il destino, se non l’auspicio, dei nostri tempi, che forse sono gli ultimi (dei tempi ultimi dice, infatti, l’Apocalisse: quindquid later, apparebit, tutto ciò che è nascosto verrà alla luce, ottimo motto che riassume l’attuale impresa planetaria del sesso).
Ma la cosa, vista per diritto o per rovescio, non sembra cambiare la sua natura: l'essenza comica di questa situazione è la cialtroneria con cui l’eros ci ha convinto della sua fondamentale importanza e desiderabilità (peccaminosa o meno). Cialtroneria che ricorda certi inganni prospettici di cui talora ci si avvede, percorrendo itinerari montani: cime che di primo acchito si impongono con perentorietà ed appaiono, dal basso, picchi dominanti, si mostrano, via via che si guadagna quota, elevazioni secondarie, o addirittura solo pareti sormontate da macchie e versanti erbosi.
Freud giudicherebbe comico (e sintomatico) questo tentativo di negare la centralità della libido. Ed ancora, si obietterà che mettere insieme eros e sesso è semplificazione di non poco conto. Nondimeno, intenzionalmente mi rifaccio ad un maestro di (apparente) semplificazione comica, Aristofane, di cui molti conoscono il mito riportato nel Simposio platonico. Del mito si ricorda quasi solo l’idea dell’integrità originaria dell’uomo e di come essa sia stata spezzata. In principio ogni essere umano era “doppio” ed era del tutto autosufficiente; era anche tracotante e borioso anzichenò, e si meritò, per il suo empio progetto di detronizzare gli dei, la punizione di Zeus, che lo spaccò a metà. Da allora ciascuno cerca la sua metà, quell’unica metà che può ricostituire l’originaria completezza, e, quando la ritrova, ad essa si unisce senza volersene più staccare. Ecco, quindi, il secondo intervento di Zeus, quello assai meno noto: per evitare che le due metà, dopo essersi ritrovate, morissero di inedia in questo abbraccio senza fine, inventò la sessualità, cioè l’atto che ha come essenza la conclusione ed il conseguente distacco.
Grandioso Aristofane: da quale lontananza di orizzonti può parlarci di un eros che, nella sua natura, istituisce un distacco, piuttosto che una prossimità fra gli uomini?

Portata quasi a viva forza in montagna, la filosofia non dovrebbe troppo dispiacersi: chissà che non vi scopra una profonda affinità elettiva. Ciò che più le appartiene, infatti, è la ricerca del rilievo, contro una strisciante tendenza a ridurre ogni cosa a monocorde pianura.
Il pensiero che dimora al piano rende tutto eguale: ognuno è ciò che è ed altro non può essere, alla fin fine ciascuno sceglie e fa quel che lo gratifica o ciò a cui lo conduce l’incoercibile sua natura, l’emozione che afferra il momento è l’unica guida nella profonda caligine del tempo, il punto di vista è l'invalicabile nicchia cui ciascuno è consegnato, tutto, insomma, è uguale espressione di quel poco o tanto di valore che appartiene alla condizione umana. Questo porre tutte le cose in piano si insinua nel comune valutare e ragionare, come condizione dell’universale interminabile chiacchiera.
Denunciare la desolazione di questa pianura potrebbe suonare come nostalgico desiderio di un ritorno ai tempi in cui di ogni cosa si faceva una questione di rango. Ma il rilievo non è il rango. Salire sui faticosi sentieri del rilievo non è tornare ad un vecchio modo di istituire facili gerarchie e di bollare con sovrano disprezzo ciò che è ignobile. Non disprezzare, ma piuttosto deprezzare dovrebbe la filosofia che osserva e risale il rilievo, togliere, cioè, la patina dell’universale commensurabilità di tutte le cose, che a ciascuna dà un prezzo, un uguale denominatore.
In montagna, sui faticosi sentieri del rilievo non si mostra una sovrana gerarchia: un'altura si scopre poggio, un picco modesta elevazione, una cima punto di incerto valore in una corona di cime che si perde nella lontananza; al termine di un cammino il camminatore solo per grazia divina, sovrumana buona sorte o imperscutabile caso potrebbe guadagnare il punto di vista sommitale dal quale indovinare, di ogni rilievo, il giusto ordine d’altezza.
Quel che conta, però, è che ciascuno si elevi, per quanto può, dalla pianura nella quale tutto giace diverso ed insieme uguale. In ciò la filosofia, passo sopra passo, non è compito di poco conto, né di pochi.

Per dissimulare la mia effettiva condizione, di badante della filosofia, mi do un po’ l’aria di discepolo ed ho deciso, per sostenere la parte, di accingermi ad una sorta di esercitazione su un terreno che le sia più che familiare. Tenterò nientemeno che di dimostrare l’esistenza di Dio. Ho tratto l’ispirazione di questa prova dall’osservazione dei panorami montani che sono tutto un repertorio di asimmetrie (quando non dissimmetrie). Per questo destavano fastidio allo sguardo di hegel, che non vi scorgeva traccia di logos (e che finì per convincersi, appunto, che la natura è il rovescio del logos, quindi trionfo dell’accidentalità e dell’arbitrio).
Ma vengo subito al punto. La realtà umana dimostra una spaventosa dissimmetria fra bene e male, a tutto vantaggio di quest’ultimo. Il suo strapotere crea un’assurda perturbazione del kosmos che può essere sanata solo presupponendo che esista, nella dimensione che sovrasta il tempo, uno strapotere del bene. Vogliamo chiamarlo Dio? A rigore, questa conclusione è semplicemente azzardata.
Ma quel che importa è guardare in faccia questo strapotere.
Troppi e troppo clamorosamente evidenti sono i vantaggi del male rispetto al bene.
Il male può colpire per primo e quando vuole, può scegliere il tavolo sul quale giocare, può mutare le regole a proprio piacimento, mentre il bene è inchiodato alla correttezza. Il male non ha perplessità, non ha dilemmi, non ha scrupoli. Di più: solo quando è mediocre viene biasimato, ma quando è davvero grande suscita spesso ammirazione e quando è davvero smisurato lo si può vedere solo da una certa distanza (temporale), perché nella prossimità temporale scompare agli occhi dei più proprio per la sua enormità. Unico efficace argine di questo male è che esso, come ogni grande cosa, genera sazietà, e possiamo quindi per un certo tempo respirare al riparo di questa sazietà.
In buona sostanza, il male sarà pure banale, a dar retta alla Arendt, ma sicuramente è radicale, come afferma anche Kant, e solo con profonda malafede l'uomo inventa sempre nuove fantasiose forme della sua proiezione fuori di sè.
Nella spicciola esperienza della quotidianità del male si mostra il fascino della redenzione possibile e del malvagio si spia e si loda copiosamente ogni spiraglio di ravvedimento, addirittura se ne osanna la conversione; se poi non si converte, sarà sempre un potenziale convertito.
Il male esercita una sorta di fascinazione, di cui sono espressione anche diverse leggende di ambientazione montana, che mettono in guardia dal pericolo di soffermarsi presso le sue incarnazioni (due, in particolare: il basalèsk, basilisco, che uccide chi presta orecchio al suo fischio o guarda nella sua direzione, incontrando il suo sguardo; i cunfinàa, malvagi relegati, dopo la morte, nei luoghi più solitari e remoti e condannati a dar di mazza in eterno, rompendo innumerevoli massi: guai a chi, udendo i loro colpi sordi e cadenzati, rallentasse il passo e si lasciasse vincere dalla curiosità).
Il bene, invece, viene davvero apprezzato solo se è senza residui; ad essere buoni ad intermittenza si alimentano solo aspettative che, deluse, suscitano più risentimento che gratitudine. Il bene viene fin troppo presto ad uggia: ad essere buoni si ha moltissimo da perdere, perché si diventa condanna vivente dei più, che buoni non sono. Del resto la vicenda di Gesù Cristo è fin troppo eloquente.
Se il bene sublime suscita ammirazione ma anche tentazioni omicide, il bene mediocre non pare aver alcun pregio. La sua colpa apparente è di essere insipido. La sua colpa reale è di essere troppo ignavo e neghittoso. Qualunque prepotenza, per quanto minima, venga lasciata correre per mero amore del quieto vivere, moltiplica il male. Di questo il non prepotente dovrebbe farsi carico. Ma, come la dolente esperienza di chi vive in montagna insegna, al buono troppo spesso viene negata non solo la felicità, ma anche l’energia che meriterebbe.
Il bene soccombe anche per dabbenaggine. Appunto: la qualità dell’essere dabbene. Il male conosce fin troppo bene il bene, ma di rado accade il contrario.
Potenza del male è anche la sua onnipervasività: si insinua nelle manifestazioni del bene inquinandole, si annida nel fondo dell’anima umana come vanagloria, amor proprio, intaccando così la purezza dell’azione apparentemente buona. Il male invischia nell’opaca trama della sua complicità, insinua la convinzione che in fondo non c’è nulla di male nel fare quel che per lo più si fa (dalle più banali alle più efferate scelleratezze).
Il male ha una potenza di replicazione impressionante: chi lo subisce, difficilmente riesce a non amplificarlo cercando qualcuno che, con la sua sofferenza, lo risarcisca del male subito. Ciò si riconduce alla considerazione generale che l’infelicità è contagiosa, mentre purtroppo la felicità lo è molto meno (chi è felice sente molto meno il bisogno di diffondere intorno a sé felicità di quanto chi è infelice senta il bisogno che anche gli altri lo siano).
È raro conoscere persone dedite a rallegrare quotidianamente l’altrui esistenza. Molto meno raro è imbattersi in persone che nulla fanno per attenuare il disagio arrecato agli altri, anche se ciò costerebbe loro ben poco.
Le conseguenze del male subito spesso accompagnano l’intera esistenza; di rado si può dire lo stesso per il bene ricevuto.
Le dispute teologiche sull’inferno trascurano la capacità tutta umana di creare non uno, ma un variegato campionario di fantasiosi inferni. Bastano piccoli esperimenti per sperimentarne qualcuno. Basta mostrare la propria debolezza, basta essere ridotti su una carrozzina, per sperimentale l’infernale malvagità di un diniego, di una piccola mortificazione che null’altra ragione hanno se non di farci avvertire fino in fondo la nostra impotenza.
I filosofi hanno talora detto che l’uomo vorrebbe essere un dio per l’altro uomo. Mi pare un’esagerazione enfatica. Gli basta essere artigiano che forgia piccoli inferni quotidiani.
Ci si dovrebbe seriamente interrogare sul motivo per cui lo spirito per eccellenza votato al male sia chiamato anche “Lucifero”, portatore di luce. Forse perché immagine del bene non è la luce, ma piuttosto (come intuito dai grandi mistici) la tenebra, il silenzio. Tenebra e silenzio, infatti, sono le più fragili fra le realtà, basta un nonnulla per squarciarle, per violentarle. Così anche il bene: più delicata fra le cose, solo qualche rara volta riesce a sorprenderci come il silenzio di certi scenari montani. Per pochi attimi. Prima che sia di nuovo l’osceno sussurrare delle cose.
Non ne farò niente di questa dimostrazione. Se la leggesse la filosofia, mi direbbe che è più poesia (senza talento poetico) di quanto non si esercizio di logos. Già, il logos. Quel bambinone mai cresciuto che trapassa con faciloneria e con sguardo presbite le cose umane.

Si dice che i montanari siano laconici. Non mi pare particolarmente vero: direi che i montanari laconici sono particolarmente laconici. Come quelli ciarlieri sono particolarmente ciarlieri. Del resto la parola, in una dimensjone spesso segnata da una solitudine angosciante, è un'ottima compagni. Per questo nessuno di loro si offenderà se approfitto di questo soggiorno montano in compagnia di una convalescente filosofia (questa sì, nella sua prostrazione, particolarmente laconica) per abbozzare una sorta di codice minimo per un'etica della comunicazione. Di essoo, com'è giusto, non restarà traccia. Spero, tuttavia, che resti un qualche sentore della necessità che la comunicazione abbia una sua etica.Chi non risponde legittima qualsivoglia interpretazione del proprio atteggiamento da parte di chi non riceve risposta.Contro Kant, che affermava l'imperativo categorico di dire la verità, ma non tutta la verità se non richiesta: di tutto ciò che non si
dice (silenzi, omissioni, reticenze) si è tanto responsabili quanto di tutto ciò che si dice.Non voler farsi capire è una piccola strategia di potere ignobile (cioè indegna della nobiltà dell’essere umano come soggetto che, aristotelicamente, ha il logos, il pensiero e la parola).Il non chiedere di poter capire è uno sciocco senso di inferiorità di fronte a chi non ha alcuna superiorità (ovvero: si è inferiori nolo nel non saper esigere la chiarezza sempre dovuta nella comunicazione).Il non saper ascoltare priva del diritto di essere ascoltati.Particolarmente ignobile è la comunicazione reticente (dire e non dire, lasciar intendere, alludere): se è lecito decidere di non comunicare su qualcosa, una volta che si è deciso, invece, di farlo ogni mezza misura offende la dignità dell’altro (cui si parla, di cui si parla).Più ignobile ancora è l’effetto annuncio che sfrutta una caratteristica dell’ethos del nostro tempo: tutto ciò che vien detto, per il solo fatto di venir detto, configura già una sua qualche forma di realtà, “realizza” se stesso. Ciò svilisce la parola e la relega in una dimensione nella quale non vi è più, semplicemente, la realtà, ma una qualche realtà.Il rifiuto della comunicazione è nascondere a se stessi il volto dell’altro: non vi è nulla di più devastante, ma anche, talvolta, nulla di più dignitoso e perfino pietoso (verso gli altri, verso se stessi).La comunicazione vessatoria, il voler dire e ridire forzando la persuasione (l’opposto della non-comunicazione) è una forma particolare di violenza, paragonabile a chi vuole a tutti i costi, con modalità assillanti, veder corrisposto un proprio sentimento.Comunicare è molte cose, anche affetto, intimità, alleanza: chi tradisce l'intimità della confidenza, rivelando ciò che in essa vien detto (caso tipico: dicendo a terzi quel che di male vien detto su di loro) è inqualificabile.Chiunque comunica deve responsabilmente mettere in conto che vi sarà, grande o piccolo che sia, un fraintendimento. Per questo la chiarezza deve essere la sua prima preoccupazione (posto che voglia davvero essere capito).Non ci si dovrebbe mai dimenticare di comunicare con se stessi.Parlare per conto o in nome di altri configura una responsabilità tremenda ed espone ad una tremenda tentazione di ybris (la tracontanza cieca ed estrema), soprattutto se questi altri è Dio.
Afferma Adorno, da quale parte nei suoi “Minima moralia”: sei amato laddove puoi mostrare la tua debolezza senza ricevere in risposta la forza. Non mi pare sia sempre vero: la debolezza innesca, ma spesso anche disinnesca l’aggressione. Direi piuttosto: ti vogliono davvero bene (eviterei, per pudore, di chiamare in gioco l’amore) laddove, quando racconti di un tuo dolore, non ha come risposta il racconto di un dolore altrui (presentato come almeno eguale al tuo), ma un composto stupore. Lì sei davvero visto.
Ancora. Chi, al racconto di un dolore, non riesce a trattenere l’impulso di intonare il controcanto di un altro dolore ha tutta l’aria di dire: ognuno ha il suo proprio dolore. In realtà con il suo atteggiamento nega proprio questo. Il dolore, infatti, è davvero dolore di ciascuno, dunque è quanto di più unico ed irripetibile una persona possa esprimere nella vicenda umana. Nel gioire, nella felicità, addirittura, finiamo per assomigliare un po’ tutti. Il dolore, invece, intaglia, in ciascuno, quel volto che è davvero e solo suo. Dunque il controcanto del dolore al dolore offende nel profondo questa unicità. Chi lo intona è persona di scarsissima sensibilità ed intelligenza: disprezza nel profondo la persona che si abbandona alla confidenza, e neppure lo sa. Molto meglio chi, non potendo entrare davvero in consonanza con questo dolore, affetta una mestizia di circostanza. Molto meglio.
Ancora: difficile trovare qualcosa di più triste e tristo dell’intessere racconti del dolore nelle circostanze che raccolgono le persone intorno al dolore di qualcuno. Se vi fosse davvero una pena del contrappasso nell’esistenza temporale degli uomini, chiunque parli appena più del necessario (di cosa, non importa) in una camera mortuaria o ad un funerale, dovrebbe ritrovarsi con la lingua disseccata.

FILOSOFIA DELLA MONTAGNA: QUASI UNA PARODIA
La filosofia mal si adatta ad un mero soggiorno montano. Reclama lo spazio suo proprio, vuole essere non solo filosofia in montagna, ma filosofia della montagna. Non riesco ad assecondarla se non in modo piuttosto grossolano, parlando un po’ della diversa filosofia che porta con sé (o da cui è portato) chi in montagna si reca. Non parlo di chi da sempre ci è vissuto (una minoranza sempre più sparuta ed anche un po’ spaurita, al di là della sufficienza di facciata, dalle diavolerie tecnologiche di cui si mostra armata la schiera di chi alla montagna fa visita): ci vorrebbe qualcosa di più di un rapido schizzo per rendere giustizia di una dimensione così sofferta, essenziale e per certi aspetti disumana, cui è stato costretto chi alla montagna ha dovuto ritagliare con pazienza tutta montanara ogni lembo di spazio, con la discrezione ed il timore di chi può sempre attendersi che la montagna tutto si riprenda.
In montagna sono andati e vanno gli alpinisti di ogni epoca, nei quali si perpetua quel profondo carattere agonistico della nostra civiltà che dobbiamo, probabilmente, ai Greci antichi. Importante fra le cose importanti è, qui, l’agone, la sfida, la conquista, il primato (la primazia, forse, nella quale rivive l’antichissimo e signorile diritto conferito ad Adamo, dare il nome a tutte le cose). Contro questo pathos della conquista e della vetta, da diversi decenni si è affacciata una nuova filosofia, quella che esalta il gusto di scalare per sé preso. Resta l’idea della sfida, con se stessi, però, e con i propri limiti, non con la montagna. Un blocco, una parete quale che sia, vale una cima prestigiosa. Non si fa più questione dell’inviolato e del violato, ma della sfida sempre più estrema fra la legge di gravità (con buona pace di Einstein, ci siamo troppo affezionati per non parlarne più) ed una sorta di primigenio impulso alla leggerezza estrema.
A parte sta una categoria giustamente negletta, cui appartiene chi scrive, quella dei consumascarpe (espressione più felice non saprei trovare). Costoro se ne vanno in montagna per il gusto di girovagare. Sono piuttosto pavidi, per certi aspetti anche pigri (quindi la fatica è un’autopunizione che si infliggono per qualche oscura colpa di cui nulla sanno). Girano qua e là rubando scorci, immagini ed emozioni. Quanto ai propri limiti ed alla sfida con se stessi, ogni tanto vi si cimentano, ma senza troppo entusiasmo, perché questi limiti sono davvero troppo imponenti perché valga davvero la pena di spostarli un po’ più in là. Quando le scarpe ormai logore segnalano che il chilometraggio (verticale ed orizzontale) si è fatto importante, pensano con una punta di orgoglio di poter essere ammessi, anche se piuttosto marginalmente, all’eletta schiera di coloro che della montagna hanno un’esperienza “consumata”.
E poi c’è chi in montagna ci va per passeggiare occasionalmente, chi per motivi climatici, chi per ritemprarsi e disintossicare mente e corpo. E poi c’è un sacco di altre persone che ci va per qualche altra ragione. Come in tutte le dimensioni dell’umana vicenda, le ragioni della gente danno sempre troppo filo da torcere all’esercizio della ragione, incatenata, come Prometeo, alle sue categorie troppo rigide.

Da Aristotele a Gadamer, l’idea che l’arte, in particolare la letteratura, rivesta un particolare valore di verità, e dunque riveli la realtà non nella forma dell’accidente, ma dell’essenza, è ben radicata nella cultura occidentale. Credo però che questa prospettiva possa anche essere rovesciata. Credo che la letteratura e, dal secolo scorso, la cinematografia, che si propongono spesso di parlare della realtà umana, rivelandone gli aspetti più profondi, siano, in realtà, tra-sfigurazione della realtà, cioè disegnino una dimensione che è essenzialmente altra rispetto a quella umana. L’immaginario, si potrebbe dire. Un immaginario de-realizzante, nel quale:accade che due o più persone parlino, una alla volta, ciascuna ascoltando le altre, comprendendole e rispondendo in modo pertinente;accade che ogni momento, ogni accadimento abbia pregnanza di significato nell’economia del tutto di una vicenda che si svolge, cioè si sviluppa (niente tempi morti, niente latenza del significato: ogni istante è essenziale, rivelatore, paradigmatico,…)Tutto ciò è situazione-limite nella condizione umana, per lo più segnata dall’opacità della comunicazione e dalla vischiosità del tempo routinario che scorre senza sviluppo, verso nessuna risoluzione.
L’arte realizza quella che Gadamer chiama la “trasmutazione in forma”; non però, credo, nel significato gadameriano di una luce gettata sul senso profondo dell’esistere e dell’essere, quanto piuttosto nel significato della costruzione di una dimensione che tanto potere ha sull’uomo, quanto è estranea alla sua condizione. La forma, appunto, che solo nell’immaginario si costituisce. L’esistenza è altro. Abbozzo, nostalgia, forse, di una forma. O forse anche l'orrore vegetale di sartriana memoria, che dà di sé le più terrifiche epifanie nei piccoli nuclei montani mangiati, anno dopo anno, dal caos verde.
Ciò che condivido con i filosofi non è il talento (o il genio, o l’onesto lavoro quotidiano sui concetti), ma una certa stizzosità ed una mediocre vendicatività. Constatato che, in questo soggiorno, non ho fatto colpo sull’augusta signora (sempre più assorbita in una sorta di autocommiseratoria ipocondria), voglio irritarla dialogando con un grandissimo poeta filosofo, quel Leopardi di cui invano cercheremmo traccia nei manuali di filosofia (e, prima ancora, nella tradizione accademica della stessa). Traggo spunto da un passo dello Zibaldone, testo che ha, fra gli altri, il pregio di lasciarsi leggere, anche a scuola, anche da studenti piuttosto distratti:
“[76] La somma felicità possibile dell’uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una speranza riposata e certa di un avvenire molto migliore, che per esser certa, e lo stato in cui vive, buono, non lo inquieti e non lo turbi coll’impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro. Questo divino stato l’ho provato io di 16 e 17 anni per alcuni mesi ad intervalli, trovandomi quietamente occupato negli studi senz’altri disturbi, e colla certa e tranquilla speranza di un lietissimo avvenire. E non lo proverò mai più, perchè questa tale speranza che sola può render l’uomo contento del presente, non può cadere se non in un giovane di quella tale età, o almeno, esperienza…. Un corollario del pensiero posto qui sopra possono essere delle osservazioni sulla vita degli anacoreti senza disturbi e colla speranza quieta e non impaziente del paradiso.”
Al notissimo tema dell’illusione leopardiana aggiungerei, per chiudere la circolarità del volgersi del tempo, il riferimento al passato, dimensione ancor più significativa dell’illusione. Quel che il passato ci riconsegna nel ricordo consolatorio, infatti, non è quel che davvero fu, ma piuttosto quei frammenti di felicità che tali si mostrano ora, nell’illusorietà del ricordo. Brandelli di reverie, echi lontani ed indistinti, angelus vaghi, immagini sciolte dal duro giogo della realtà fluttuano disegnando indistinti arabeschi di qualcosa che, con infantile balbettio, chiamiamo felicità. Ma sia che si disegni il futuro, sia che si disegni il passato, sempre ci culla la mite impressione che ci venga incontro, da qualche parte del tempo, la soglia che apre all’altrove.
Provo, allora, a mo' di esercitazione, a disegnare una scena di perfetta felicità in un contesto montano. Immagino un cocente meriggio, e la fresca penombra di una chiesa, dove l'irruzione della luce non ferisce, neppure il cuore. Immaginiamo una donna, tutta raccolta nella preghiera. Una donna riconciliata con il proprio passato, con figli degni, onesti, laboriosi. Con un marito altrettanto degno, onesto, laborioso. Una donna che guarda con sguardo sereno anche al proprio futuro, nel quale si disegna un incontro con gli affetti da cui ha preso congedo nel tempo. Una donna cui la fede prefigura, dopo la necessaria purificazione, l'accesso al luogo della gioia e della luce eterna, dove sarà accolta, appunto, dai cari defunti. Ecco, mi parrebbe difficile tracciare un quadro di una felicità più compiuta, nella quale passato e futuro si curvano e si congiungono, ad anello, nella quiete della luce che non ferisce. Ed il punto di questa congiunzione è la soglia dell'altrove. La soglia dove un'incerta figura appare, ed una domanda vien su dal profondo: "Sei tu?"
Fra le molteplici attività cui fu da sempre dedita la filosofia particolarmente meritoria è la caccia alle fallacie, cioè agli errori di ragionamento nei quali più spesso incorriamo, inconsapevolmente. Fra queste porrei la “fallacia dell’unità”: tendiamo ad attribuire ad ogni realtà, con la quale non abbiamo familiarità, un'unità molto maggiore di quella che effettivamente sussiste. Accade, questo, quando frequentiamo nuovi ambienti, nuovi gruppi, nuove comunità: ci aspettiamo, dall’esterno, coesione, linearità, univocità. Lo stesso vale per l’immagine che abbiamo della “gente di montagna”. Se il tempo ci consente di guardare le cose un po’ più di fino, ci rendiamo conto di essere di fronte ad una realtà molto più variegata e molteplice di quanto potessimo sospettare. La gente di montagna, come la gente in genere, presenta l’intero campionario dell’umano. Un campionario che non si è mai terminato di inventariare.
Aristotele affermava che la filosofia nasce dalla meraviglia, ma conduce al superamento della meraviglia, perché porta a quella sapienza che di nulla più ci fa stupire. Forse le cose sono a rovescio: partiamo sempre da una serie di solide aspettative su quel che possiamo aspettarci dalla gente e dalla realtà, e, via via che l’esperienza cresce, avvertiamo sempre più la sottile angoscia di chi comprende che, alla fin fine, almeno dalla gente, non sai mai davvero cosa aspettarti. Nel bene e nel male.
Di meraviglia in meraviglia siamo condotti alla disorientante consapevolezza che l’unità è solo un effetto di lontananza, come per la visione delle cime: da lontano appaiono compatte, ma la prossimità rivela un’avvilente congerie di massi, crepe, fenditure.
Se la filosofia è sguardo testardamente fisso su quel che ci sta dinanzi (compresi noi stessi, la realtà più difficile da scorgere), il suo cammino è cammino di approfondimento della meraviglia. Che poi diventa sconcerto, scoramento, perfino, ma anche timida speranza.Chiamiamo la scarsa capacità dell’uomo di comprendere la realtà nella quale si muove anche “miopia”. E, di certo, la sconsiderata leggerezza con cui l’uomo vive nel difetto di considerazione per il proprio futuro, e soprattutto di quello delle future generazioni, non è mai a sufficienza esecrata. Ma l’esecrazione della miopia non è riscattata da una particolare capacità umana di scorgere con chiarezza ciò che sta dinanzi agli occhi. L’uomo pecca anche per un’altrettanto esecrabile presbiopia. Quanto più rivolge lo sguardo a se stesso, tanto più fatica a mettere a fuoco ciò che vorrebbe vedere. Di noi stessi e di chi siamo possiamo sapere qualcosa solo a posteriori. A cose fatte. Nel bene e nel male. Non a caso Protagora vuole che sia stato Epimeteo, cioè colui che solo a cose fatte vede, ad aver lasciato l’uomo, nella distribuzione delle doti naturali a tutte le specie viventi, singolarmente privo di doti peculiari. L’intervento a posteriori di Prometeo, che sana la situazione, non risana che in parte questa lacuna: la preveggenza di Prometeo, colui che “vede prima”, è tale solo a cose fatte. L’avvedutezza, nell’uomo, non è mai tanto avveduta da saper prevedere e prevenire la sventatezza.

Segno dell’autentica intelligenza, posto che questa espressione significhi qualcosa, è l’assenza di ogni atteggiamento sprezzante nei confronti dell’ignoranza. Il sorriso o la smorfia di fronte all’ottusità non sono affatto intelligenti. La vera intelligenza, quella lungimirante e consapevole di sé, coglie, infatti, analogicamente, l’abisso che la separa da una capacità di rappresentazione e comprensione della realtà che di gran lunga la potrebbe superare, capacità che può immaginare, senza scomodare Dio, in qualche altra intelligenza nel cosmo. In questa visione prospettica, non si può davvero tenere in troppo conto la propria intelligenza, né si può considerare con sufficienza la propria superiorità intellettuale. Ciò che all’intelligente dà fastidio dell’ignoranza è semmai la sua cieca prepotenza e supponenza. Ma ciò dà fastidio all’intelligente non in quanto intelligente, ma in quanto uomo. Per questo, forse, i filosofi, scontando un inconfessato senso di colpa per l’alterigia che di rado si accompagna alla loro riflessione filosofica, hanno spesso, con scelta assennata e piena di buon gusto, assunto Socrate e simbolo della ricerca filosofica.
Ciascuno ha da perdere, prima o poi, la sua verginità. Qualunque siano le sue scelte di vita. E questo è un evento che si ricorda, con doloroso stupore e disincanto triste. Lo ricordo in un'infanzia indeterminata, quando, chierichetto, accompagnai il mio parroco ed il suo vicario a rendere omaggio alla salma del padre della mia stimatissima maestra. Accadde subito dopo l'uscita dalla sala con la salma. Fu uno scambio di battute, di tenore vagamente scherzoso, o forse semplicemente leggero, o forse ancora semplicemente prosaico, fra i due. Qualcosa che mi colpì profondamente, perché mai lo avrei pensato possibile, dopo aver accostato un luogo così sacro, cioè così segnato da profondo dolore. Un episodio in sé, cioè alla luce del realistico disincanto, del tutto banale, di nessun rilievo. Ma sono le cose banali e di poco rilievo, in genere, che tolgono la verginità, cioè lo sguardo primigenio ed incantato che vive della convinzione di una assoluta congruenza fra quanto vien detto ed insegnato e quanto appartiene alla realtà. Accade qualcosa di simile anche in filosofia. Il fanciullino filosofico si accosta a testi e teorie rompendosi il capo. Poi capita che qualche maestro butti là con noncuranza, o con ammiccamento, qualche “dritta”, qualche scorciatoia, qualche segreto di bottega, con il tono di chi dice: “Ma alla fin fine è così che le cose stanno...”: basta questo, dunque, per suscitare il doloroso stupore che diventa domanda: “Perché questo vien detto solo dietro le quinte? Perché i filosofi non scrivono per farsi capire?”. Ma, data la stura, queste sarebbero solo le prime di una lunga sequenza di domande, fra le quali: "Perché i filosofi sono persone non di rado così meschine?"
Nihil sub sole novi. Neppure in filosofia, pare. Per questo la veneranda filosofia se ne sta a soggiornare in montagna, curandosi il male della bile nera, la malinconia. Un po' come in musica: si ha la netta impressione che quanto di grande poteva essere scritto, è stato scritto. Ha un bel dire Schoenberg, parlando delle composizioni in do maggiore che attendono ancora di essere fissate sul pentagramma. Resta il tentativo sempre più cerebrale di sperimentazione, l'incontrollata frenesia di contaminazione, rivisitazione, citazione, la prostrazione epigonale che diventa filologico cipiglio o ludica dissacrazione. Tutto, fuorché il classico. Non accade così anche in filosofia? Cosa rimane da dire? La filosofia sembra essere diventata un monumentale lascito da dissezionare (neppure vivisezionare), reinterpretare, rivisitare, contaminare. La malattia mortale della filosofia, come della fede, è la disperazione. Di sé. Forse perché l'anatema kierkegaardiano contro la disperazione estetica si estende ad un tempo, questo, profondissimamente estetico, che rifugge la ripetizione come la peste. Un segno, forse, banale, lo troviamo nel linguaggio: se gli antichi usavano la figura dell'oggetto interno (es.: combattere un combattimento), per noi l'uso reiterato di una parola a breve distanza suona di pessimo gusto. Segno della nostra civiltà è il dizionario dei sinonimi. Così come il sufficiente ostracismo ad ogni tentativo di riprendere ex novo uno stile, un pensiero. Bernardino Varisco, filosofo ai più ignoto, meriterebbe un ricordo solo per aver stigmatizzato questo imperio culturale attribuendolo ai “filosofi dell'oramai”.

L'assuefazione alle parole è un potente oppio per il pensiero. Molto spesso le parole non significano davvero quel che si vorrebbe significare, e questa distorsione non è priva di derive incontrollate. Un esempio. “Meritocrazia” è una di quelle parole che oggi spopolano, ad indicare la prospettiva di una società più giusta, emendata da privilegi, rendite di posizione, corruzione, clientelismo. Ma il merito di cui si parla non è merito, piuttosto talento. Merito è ciò che si acquisisce in virtù di impegno assiduo, tenacia, determinazione. Talento è ciò che attende sì una coltivazione, ma si ha in buona parte dalla natura. Dunque si dovrebbe parlare di “talentocrazia”, cioè di premio a chi è davvero capace. Qualunque sia la radice del suo essere capace.
Ma, poi, sentite anche questa. Dicono i bene informati che il cibo invenduto e non più commercializzabile ma ancora commestibile venga ritirato per essere eliminato come rifiuto. Nessuna beneficienza, nuocerebbe al business, diminuendo l'aliquota di potenziali acquirenti. Se i discutesse di questo problema, non pochi invocherebbero un intervento contro lo scandalo del cibo buttato a fronte della miseria. Costoro invocherebbero una questione etica. Questione etica? Da quando quest'espressione è sinonimo di "questione di decenza"?
Non bisognerebbe essere troppo severi contro coloro che parlano di complotti orditi dalle forze oscure demoniaco-massoniche o di qualche altra natura; non bisognerebbe sorridere con sufficenza di coloro che invitano a sospettare un disegno internazionale per garantire ad oscure elites un potere manipolatorio sempre più capitale ed incontrollabile. In effetti, a guardare come vanno le cose con un sguardo un po' eccentrico, un po' esterno, l'impressione è proprio questa. L'impressione di un disegno universale. Un disegno, forse un esperimento, di un'oscura intelligenza, che, per qualche incognito fine, vuol saggiare fino a qual punto di torsione può essere forzata la natura umana. Ovvero, vuole sperimentare se essa sia elastica, e quindi ritorta tenda comunque a tornare alla originaria conformazione, oppure plastica, e quindi ritorta docilmente assuma la configurazione imposta, o, infine, rigida, e quindi, ritorta, giunga ad un punto di rottura. Troppi elementi, troppi indizi suggeriscono quest'ipotesi. Ha qualcosa a che vedere con l'umana natura la strategica e capitale corrosione del senso del pudore e del ritegno? Ha qualcosa a che fare con l'umana natura il nuovo incalzante verbo che predica la competizione come orizzonte ultimo di senso? Ha qualcosa a che fare con l'umana natura lo sradicamento sistematico, la confezione di esistenze di seconda mano che ciascuno acquista al prezzo che può, la gozzoviglia di emozioni sfuse da consumare con qualsivoglia mezzo? Ha qualcosa a che fare con l'umana natura il sistematico ottundimento legato alla convinzione indotta che per ogni aspetto dell'esistenza vi possa essere una rassicurazione, una garanzia, una certezza di diritto o risarcimento? Forse si vuole creare una qualche nuova forma di umanità. Forse nessuno vuole questo in forma consapevole, ma le cose vanno così. Forse è lo spirito della storia, un qualche destino, una qualche potenza sovrannaturale. Qualcosa deve pur esserci dietro un così cosmico rivolgimento di quanto millenni di evoluzione ominide ed umana hanno mostrato della natura umana.
Tornare sui propri passi: ecco la più preziosa fra le occasioni di esercizio della saggezza offerte dalla montagna. Tornare sui propri passi perché il tempo volge al brutto, perché il sentiero è incerto, perché il terreno è difficile, perché le forze vengono meno, perché un amico fatica a seguirci, perché… Difficile, molto difficile, però, trovare la forza per farlo. Si oppone a questa decisione una delle potenze più tiranniche che sovrastano l’umana condizione, la potenza della buona forma, del compimento. Un’escursione incompiuta, come tutto ciò che è incompiuto, ci apre al sentimento del vuoto, all’orrore del vuoto. Tale è, infatti, ai nostri sventurati occhi quel che non trova il proprio compimento.
Oso un’affermazione parecchio retorica: quante sciagure sarebbero state risparmiate all’umanità, se solo gli uomini potessero risolversi a tornare sui propri passi quando si rendono conto che dovrebbero farlo! Ma farlo equivarrebbe, oltre che a lasciar qualcosa di incompiuto, ad ammettere di aver sbagliato, quindi, anche, a perdere la faccia, la cosa che, a voler dar retta a Goffman, gli uomini temono di più, in assoluto.
Non so se davvero sia così, se davvero è in questione il perdere la faccia. Di certo l’orrore dell’incompiuto si rintana nel profondo del cuore umano.
Dicono, molti, che all’approssimarsi della morte scorrerebbe nella coscienza del moribondo l’intera esistenza, come in un lampo. Mi pare, questo, più un timore che una constatazione: poter vedere in una manciata di istanti l’intera propria esistenza significherebbe, infatti, vederne la forma, o piuttosto la deformità, l’incompiutezza, e quindi essere divorati dall’orrore.
Queste riflessioni che toccano il saper tornare sui propri passi portano ad una virtù negletta e banalizzata. Non saprei chiamarla in altro modo che mitezza. Non però nel medesimo senso della mansuetudine. La prima sta alla seconda come l'innocenza sta alla bontà, come il dato originario e puramente naturale sta alla conquista, sofferta, precaria. Mitezza mi pare di poter chiamare, appunto, la capacità di lasciare che le possibilità scivolino via senza volerle tutte afferrare. Ma anche, e soprattutto, lasciare che le forme di cui tracciamo il disegno nell'esistenza possano essere quel che finiscono così spesso per essere, deformi, sgraziate, incerte, inconcluse. Persona mite è quella che trattiene l'impulso a dar fondo, ad esaurire. La mitezza lascia spazi aperti. Non solo oltre, ma anche in quello cui poniamo mano.
Difficile virtù, la mitezza. Soprattutto, rara, e facilmente confusa con la misura. Misura è saper commisurare le forme del nostro agire a quanto è davvero alla nostra portata. Mitezza è accogliere la possibilità che queste forme restino anche al di sotto di quanto è alla nostra portata, non realizzino tutto ciò che appartiene all'arco delle nostre possibilità.
Bisognerebbe poter scrivere una grammatica, e poi magari anche una logica dei nostri piccoli piaceri quotidiani, riordinare, rinnovare, rassettare, ripulire. Così come Richard Strauss non ha disdegnato di comporre una sinfonia domestica, bisognerebbe trovare qualcuno che mettesse mano ad una filosofia domestica, cercando di vedere dove conduca il filo che rannoda questi piccoli piaceri. Così, tanto per cavarsi il gusto di un piccolo piacere nel pensare. Che non è molto diverso da un ambiente domestico, dalla nostra casa.
La filosofia, da sempre affezionata alle cose linde, non protesterebbe troppo, quand'anche le restasse l'energia sufficiente per farlo.

L'aforisma del malinconico ed oscuro Eraclito “Polemos (il conflitto) è padre di tutte le cose, di tutte è signore” si riferiva alla guerra per la quale, nel mondo, gli opposti, tragicamente e reciprocamente, si lacerano ed insieme si implicano. Eccellente esempio di proiezione dell'umano nel cosmico. Accorciando di molti il respiro, potremmo trasporlo al mondo degli intellettuali. Probabilmente anche a quello dei filosofi. Ciascuno, infatti, vi trova identità proprio nel conflitto, posizione nella contrapposizione. La verità, in un tale scenario, appare quasi più solo come pretesto. Ciò spiega l'inspiegabile lapsus per cui la filosofia ha assunto tale nome (che significa, com'è noto, amore di sapienza) piuttosto che quello, più ovvio all'occhio ingenuo, di filaletìa (amore di verità). Questo è uno dei motivi per cui è così difficile leggere di cose intellettuali, per non dire di quelle filosofiche. Per una elementare esigenza strategica, celare è importante tanto quanto palesare le proprie forze ed i propri argomenti (quando ve ne sia qualcuno, di argomento). In questo siamo davvero eredi dello spirito profondo della civiltà ellenica, uno spirito agonistico. In questo davvero la nostra civiltà (intellettuale, e non solo) è un'agonia.
Pensare di pensare è ancora pensare? No, è ingannarsi. Cioè: si pensa erroneamente che l'attività vigile e la coscienza coincidano con il pensiero. In realtà si tratta, per lo più, di automatismi e di corti-circuiti consolidati. Non sono poche, ad esempio, le espressioni che, qualora venissero pensare, si mostrerebbero di significato ben diverso, quando non contrario, rispetto a quello assunto per automatismo. Quattro esempi.
Quando ad un docente si chiede di valutare con un metro largo si dimentica che il metro largo produce, nella misurazione, valori numerici... stretti.
Quando, poi, di discetta di libertà, irresistibile è la tentazione di porre sul tavolo la massima che dovrebbe sciogliere tutti i dilemmi: la mia libertà finisce dove inizia quella degli altri. E si crede di aver espresso un profondo concetto. Ma l'espressione non è niente più che una tautologia, un condensato di ovvietà assoluta, un po' come dire che il territorio nazionale italiano finisce là dove inizia quello elvetico. Sai la scoperta! Il problema qui non viene risolto, ma occultato dalla suggestione delle parole. Il problema, quello vero, quello non pensato, è di capire qual principio o fondamento permetta di mediare o decidere fra libertà che confliggono, spostando, appunto, il confine un po' più in là o in qua.
A proposito di questioni di grande spessore: se qualcuno le chiama in gioco quando si discute di problemi, diciamo così, più “pratici”, viene tacciato di avere una visione “ideologica”. Ora, “ideologia” vale, nell'accezione ormai invalsa nell'uso, “visione complessiva del mondo e dei valori, rigida, non negoziabile”. Quando si accusa qualcuno di avere una posizione ideologica, talvolta si coglie nel segno, ma quasi sempre si protesta in nome di un'inconsapevole ideologia, quella dell'utile di breve respiro Anch'essa rigida e non negoziabile.
Infine: molti interpretano la frase “Non potrei vivere senza di te” come massima espressione dell'amore. Ma, a rifletterci un po', forse lo è quella contraria, cioè “Potrei vivere senza di te”. A patto, ovviamente, che uno aggiunga “Ma ti amo e non vorrò mai farlo”. Perché l'amore è un dono, non una dipendenza.
La benevolenza di cui godiamo è misurata da quanto gli altri sono disposti a perdonarci. Detto così, sembra del tutto banale. Non è affatto banale, però, osservare con quanta diseguaglianza la predisposizione ad essere perdonati si distribuisce fra gli uomini. A taluni si perdona quasi tutto, ad altri quasi nulla. Indipendentemente dal merito. Persone irreprensibili ma insopportabilmente serie, magari pignole, perfettine, con atteggiamenti colti, a torto o a ragione, come giudicanti non avranno sconti nella colpa. All'estremo opposto stanno quelli che, con parola di rara espressività, vengon detti impuniti. Costoro non difettano di sorriso, si prodigano in ammiccamenti, per tutti hanno un gesto di complicità. Così a buon prezzo può venir comprata l'umana comprensione. Per un prezzo ugualmente modesto può, d'altro canto, essere persa.
Incredibile più di ogni altro, fra i molti aspetti incredibili della natura umana, è la facilità con la quale gli uomini riescono ad ingannare sé e gli altri. È come se avessimo pagato il balzo in avanti nell'intelligenza che ci ha portati a signoreggiare ogni altro animale con una pena del contrappasso: una stupidità senza pari quando rivolgiamo lo sguardo a noi stessi ed agli altri. Se gli animali sviluppassero una qualche forma di intelligenza simbolica e strategica, commiserando questa nostra singolare cecità non sarebbero troppo severi con noi. Finirebbero per chiamarsi “l'animale cialtrone” e riderebbero a crepapelle sentendo raccontare della nostra prima gloria filosofica, tal Socrate, noto, fra l'altro, per aver assegnato all'uomo il compito di conoscere se stesso.
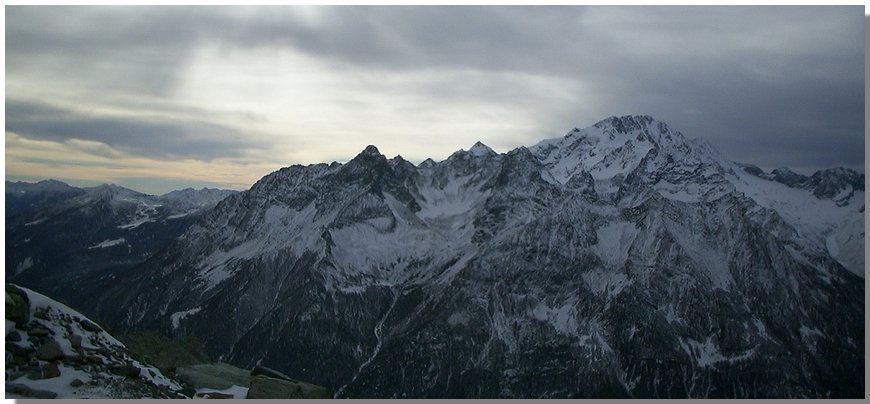
Ci sono enormi iceberg, addirittura continenti interi che vanno alla deriva. Per questo, forse, la deriva delle parole passa inosservata. Ma non ha conseguenze di minor rilievo. Ne segnalo una: l'etica, un tempo disciplina assai impegnativa e di respiro universale, oggi è finita nelle secche della semplice decenza.
Queste derive possono condurre una parola addirittura agli antipodi dell'orbe terracqueo. Così è accaduto a “paideia” (educazione): nella lingua greca il termine designava anche la punizione corporale; oggi quando si parla di un approccio “educativo” lo si contrappone decisamente all'imposizione ed alla coercizione.
Copyright © 2016 Massimo Dei Cas
Copyright © 2013, designed by Alpha Studio | Privacy Policy




